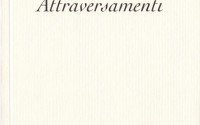Solo per ringraziare
Giancarlo Pauletto | giugno 2022 | Il Ponte rosso N°81 | la memoria
La bella vita del critico d’arte (parte decima)
Incontri, arte e amicizia con Tonino Cragnolini
di Giancarlo Pauletto
La prima cosa che posso e debbo dire di Tonino Cragnolini (1937-2014) è che fu un grande amico.
Degli amici aveva l’attenzione, la generosità, la voglia di colloquio e, infine, la regale accoglienza.Che si esprimeva anche, molto semplicemente, tagliando un pezzo dell’ottimo formaggio che sempre aveva a disposizione, e il salame, che non mancava mai. E ovviamente il vino che, di solito, veniva introdotto dalle parole: «Senti, senti questo», che fosse blanc o neri, cabernet o tocai, refosco o merlot o magari, se non c’era premura, tutti quanti, a seconda della pietanza che arrivava.
Sempre a proposito di “bella vita”.
C’è un incontro eponimo che posso raccontare, prima di parlare di arte.
Erano i primi anni ’90 e Tonino mi telefonò per invitarmi ad una cena nella quale – disse – avrei incontrato una persona che di sicuro mi sarebbe piaciuta, e anche un vecchio amico di cui non volle svelarmi l’identità.
Tonino non parlava mai “a vanvèra” – come diceva la mia prima figlia quando aveva sei o sette anni –, e quindi risposi senza esitazione alla chiamata.
Ci ritrovammo, all’imbrunire, in una osteria poco discosta da Tarcento, non lontana dalla collina di Sant’Eufemia, luoghi che per me erano ormai – in virtù di Anzil, Ceschia e soprattutto Cragnolini – un’estensione del cortile di casa.
Il vecchio amico era un mio ex studente tra i più bravi e spiritosi che continuava – allora, e spero anche oggi – il mestiere di suo padre, seguiva la vite e il vino – ottimo, altrimenti non si sarebbe trovato dalle parti di Tarcento, e specialmente a casa Cragnolini –; si trovava in loco perché aveva appena portato un robusto rifornimento alla cantina del nostro ospite.
L’altra persona era un prete, di faccia simpatica ed aperta, di stazza piuttosto robusta. Intuii che doveva essere un prete particolare, altrimenti non sarebbe diventato facilmente amico del mio amico.
E infatti.
Gilberto Pressacco, teologo, umanista, musicista e musicologo era una delle più brillanti, complesse e fascinose figure intellettuali del secondo Novecento friulano, ma io ancora non lo sapevo. Cominciai a rendermene conto però, sia pure a tentoni, nel corso di quella indimenticabile serata, che ebbe inizio con un aperitivo di vino e fette di salame, continuò con l’ovvia pasta e fagioli, proseguì con una straordinaria frittata “cu li arbis” e si concluse – ma si fa per dire – con molto, squisitissimo frico, e con una zuppiera di radicchi.
Del vino non serve parlare.
Si ribaltò il mondo, naturalmente, ma poi venne fuori il discorso sulla musica, su Mainerio, sul Menocchio di Montereale, su Aquileia e il discanto, e sulla villotta: prima ero stato soprattutto ad ascoltare, ma sulla villotta no.
Chiesi a Pressacco come fosse possibile che la villotta, questo monumento poetico e musicale, fosse così maltrattata nella sua patria: non c’era, a mia conoscenza, una corale che la cantasse come si deve, la villotta: una delle pochissime creazioni originali che il Friuli potesse vantare a suo onore imperituro, almeno fino a quando una lingua, una poesia e una musica avessero avuto ricetto presso qualche friulano.
Pressacco non mi dette torto, anche se mi obiettò che magari qualcuno c’era, che la cantava discretamente – omise di precisare che si trattava del coro da lui diretto, il “Candotti” di Codroipo.
Io insistevo: «Come si fa a tirar via una meraviglia quale Ce bielis maninis, oppure Non sta fa’ la pinsirose, o magari Lait a rosis. Bisogna sentire la Sat di Trento cantare L’è ben ver che mi slontani, o Ai preat la biele stele, per capire cosa può essere la villotta; o magari, o anche, il Quartetto Stella alpina di Cordenons, quelli sì che sono bravi, pur con qualche eccessiva concessione al popolaresco, e tuttavia sono bravi, cantano con una sensibilità in punta di voce».
Io mi infervoravo perché alla villotta ci tenevo e ci tengo, essendo stata, si può dire dalla mia infanzia, una delle principali porte attraverso cui sono entrato nella musica; Pressacco commentava che c’era tutto un grande lavoro di educazione da fare, nel settore musicale: lui, che è stato anche in questo ambito uno dei massimi educatori friulani.
Aveva scritto da poco – seppi, e lessi dopo – un acuto testo sul Bertrando di Tonino, uno dei cicli più importanti, assieme alla Modesta proposta, alla Zoiba, al Castello di Fratta e al Purcità, che egli avesse completato.
In quel testo Pressacco leggeva il trittico di Bertrando da Saint Geniès, patriarca d’Aquileia – assassinato il 6 giugno 1350 sulle ghiaie della Richinvelda da una congiura di feudatari friulani – come scontro tra la plebs difesa dall’energico uomo di chiesa e il potere feudale che non voleva opposizione: «Tonino Cragnolini, negromante nelle oscure e lunghe notti che precedono l’alba del terzo millennio, evocando l’imbalsamata ombra del patriarca Bertrando fa in modo che “noto ci sia” che non v’è progresso, né ci sarà millennio a cui sia stata garantita l’immunità da un potere violento e crudele che elimina fisicamente gli ostacoli che si parano dinanzi alle sue insaziabili avidità di dominio assoluto ed omologante. I potenti trinitari network dei contemporanei mass media – profeticamente esecrati dall’inascoltato Pier Paolo Pasolini – non sono che la facilitata e tentacolare protesi delle ghigliottine razional(izzant)i e dei comburenti roghi inquisitoriali, alla faccia del rudimentale triregno del biat Baltram».
A mezzanotte il nostro amico portatore di vino se ne dovette tornare, invece Tonino Gilberto e io non avevamo alcuna voglia di smettere di mangiare, bere e chiacchierare.
Così ci rifugiammo nella cantina del nostro ospite, in cima a Nanarià, Loneriacco: una cantina in cui certo non mancavano le munizioni da bocca.
La faccio breve.
Le ore piccole cominciavano a farsi più grandi quando, piuttosto cinci – questo è, invero, un pleonasmo – intonammo l’ultima villotta in faccia alla valle del Torre, nella notte stellata che schiariva ad oriente ed era, questa villotta, Al cjante il gial.
Che infatti cantava.
Capito perché questa sequenza di raccontini è intitolata Solo per ringraziare?
Ma occorre aggiungere qualcosa sull’arte di Cragnolini, che conobbi di persona quando ancora abitava Oltretorre, ma come artista già nel 1963, per una sua mostra presso i “Mulini” di Portogruaro.
Essa già inscenava il suo sguardo satirico sulla sopraffazione sociale, uno sguardo che via via è andato sempre più in profondità, diventando meditazione storica suscitata da fondamentali testi letterari, da Beckett a Swift a Nievo, e da famosi eventi storici friulani, come appunto la Zoiba e il Bertrando.
Nessuno come lui ha espresso, in Friuli, attraverso atmosfere cupe, grottesche e feroci, la dannazione costante dell’Homo homini lupus, e nessuno ha visto con più lucidità – in immagine –l’origine di questa dannazione – la fame, la lotta per il cibo.
Come è chiarissimo nella indimenticabile serie del Purcità: acqueforti talora tinte di rosso in cui omini frenetici, armati di scale e coltellacci, si affannano attorno e dentro la carcassa del maiale, proteine indispensabili alla vita: la quale non avrà pace – è il messaggio ovvio e sottinteso – fino a quando quel problema – anche, e forse ancor più nelle sue implicazioni metaforiche, che chiamano in causa ogni sorta di potere – non sarà risolto per tutti, al mondo.
Sapendo benissimo lui, come sappiamo noi – oggi che capi di stato viaggiano con valigetta nucleare appresso – che tutto potrebbe finire in un bel rogo atomico molto prima che l’auspicio si avveri.
L’ultimo incontro fu poco prima della sua morte, ancora sulla collina di Tarcento, dove un vecchio amico aveva un prefabbricato al quale saliva quando doveva attendere alle sue viti e al suo vino, e per feste con le persone più vicine.
Eravamo in sei, e l’ospite girava dall’uno all’altro a versare il “nostran”, che faceva e curava con infinita passione.
«Siamo gli ultimi, siamo gli ultimi» mi ripeteva all’orecchio, e intendeva dire che altri non ci sarebbero stati, dopo di noi, a godere di quel posto e di quel vino: e intendeva anche dire – indicando sulla parete di legno un grande manifesto che rappresentava Geronimo, grande capo degli Apaches – che la gente non sapeva più godere come si deve di quelle semplici cose.
Tonino si sforzava di sorridere, beveva un mezzo dito di vino, mangiava appena un pezzettino di frico.
Fu un addio malinconico, ma anche giusto, tra compaesani e amici che egli aveva cari da molti anni.
Tonino Cragnolini
Maschera
1983