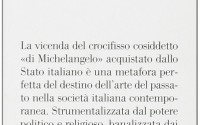Australia 14: Sydney
Il Ponte rosso N° 16 | Pericle Camuffo | settembre 2016 | viaggi
Camminare è una continua narrazione, come sostengono da sempre gli aborigeni
Aspetto un’ora davanti al ristorante a riempirmi d’angoscia per ogni ragazza che si avvicina, ma nessuna è lei
Il posto dove andrò, tra qualche tempo, ad appoggiare le mie nuove barchette di carta cariche di sogni e di domande, prima di ripartire
di Pericle Camuffo
Paul, l’amico a cui avevo consegnato la roba prima di partire, mi ha lasciato la sua casa per un mese. È andato in Tasmania a trovare la sorella.
Sono seduto da un po’, per terra, nel salotto, a mangiare patate fritte troppo salate, sei lattine di Foster’s, Tom Waits che gracchia nella sua voce di ferro arrugginito, leggendo una biografia di Carlo Michelstaedter che non mi porterà da nessuna parte, mentre nuvole trascinate dal vento come carri vuoti corrono pazze sul cielo di Bondi. Ma sto bene qui, con tutte le mie domande sparpagliate sul pavimento come fossero carte da gioco, e forse lo sono, solo che io non conosco le regole per giocarci. Le guardo e capisco il valore di ognuna di esse, ma non capisco il loro stare assieme, come entrano in relazione l’una con l’altra. E lì in mezzo, tra le carte colorate, c’è quel foglietto ormai unto e stropicciato che mi sono rigirato tra le dita da quando sono tornato in città. È il pezzo di carta che mi ha lasciato Jasmine, la ragazza che ho incontrato allo Stone Wall e che mi ha accompagnato nella magia di una delle mie ultime notti in città. Sul foglietto c’è il suo numero di telefono. Solo il numero, senza il nome. Dieci cifre come dieci note in fila, che per me sono le note di un ricordo, le sue note, la sua musica.
È già da un po’ che penso se chiamarla o no, ma non sono sicuro di avere il diritto di entrare ed uscire dalla vita di qualcuno, dal corpo di qualcuno, e se questo via vai non comporti anche una sorta di responsabilità. E poi non l’ho fatto anche perché non mi va di sentirmi dire “Ah sì, ciao, e chi cazzo saresti?”
Fuori dalla finestra, il solito casino variopinto di Bondi, tra corpi scolpiti da palestra e vitamine e onde di ghiaccio che sorreggono surfisti annoiati chiusi in guaine di gomma scura, baracchini di bibite e gelati e la macchia della polizia che va su e giù con una lentezza stancante. Osservo tutto questo, ma sento che in qualche modo il mio corpo sta perdendo spessore, che si riduce a membrana molle e sottile e tutto mi passa attraverso come se non incontrasse resistenza, lasciando solo leggeri granelli di polvere.
Ho perduto i pezzi della mia esistenza da qualche parte, forse a Kings Cross, in quel parcheggio, forse laggiù nell’outback, o forse mi sto semplicemente sgretolando come una statua d’argilla troppo secca e troppo vecchia. Sto scomparendo. Non che stia morendo, niente a che fare con la morte, ma sto perdendo consistenza davanti a questo sole chiaro e puro. Sono di fronte ad una delle più famose spiagge del mondo, e non riesco a trovare un senso a questo mio essere qui. Non so più che fare. Finché corri hai sempre la strada che ti si apre davanti e quell’apertura infinita in qualche modo completa la tua inconsistenza. Il movimento ti sorregge, gli occhi continuamente pieni di cose che cambiano, anche se solo nel grado di sfumature e riflessi. Camminando, ha detto in un’intervista Reinhold Messner, le cose ti si mostrano, ti si raccontano, e tu racconti a loro te stesso. Camminare è una continua narrazione, come sostengono da sempre gli aborigeni, è un canto, e all’interno di questo canto, diventi spirito. Quando ti fermi, è come se la musica finisse di colpo, come se la comunicazione tra te e il mondo si interrompesse, e non serve a niente mischiarsi tra la gente, nascondersi.
Capisco che mi serve della musica per tirare avanti, che mi serve un’altra strada su cui camminare, un’altra direzione, un altro viaggio. Tiro su il telefono e faccio il numero. La voce di Jasmine non trema né esplode di gioia, ma rimane quasi piatta, trascinata in lunghe pause d’ascolto in cui io tento di spiegare o giustificare quella chiamata, finché mi interrompe dicendomi che non devo spiegare niente, non a lei, non in questo momento. Ci diamo appuntamento per il pranzo al Thai on wok, un locale a Glebe, dove lei vive con un’amica.
Arrivo un po’ in anticipo all’appuntamento, così faccio un giro al mercatino del sabato che è un salto indietro negli anni Sessanta. Sembra di essere a qualche raduno hippy, tra incensi, vestiti psichedelici, dischi in vinile, oggetti di ogni tipo, cose usate e strausate, cibo indiano cinese nepalese, cibo macrobiotico e biologico, bandiere e spettacoli di mimi e acrobati e musica jazz illusionisti e tante, ma tante belle ragazzine figlie dei fiori e di nostalgia nei loro capelli lunghi e nastrini colorati e un sorriso di pace amore e libertà imparato sui libri o copiato da fotografie e vecchi film in vhs.
Ma mentre attraverso la strada per andare ad incontrare Jasmine, mi rendo conto che non mi ricordo bene la sua faccia. E più mi avvicino al locale e più mi rendo conto di questo, più mi convinco che farei meglio a tirare via diritto e ritornarmene a casa per evitare qualche spiacevole imbarazzo. Aspetto un’ora davanti al ristorante a riempirmi d’angoscia per ogni ragazza che si avvicina, ma nessuna è lei. Poi mi telefona, si scusa, non ce la fa a raggiungermi. Vuole il mio indirizzo e passerà lei da me, più tardi. Invece del pranzo ci sarebbe stata una cena. Meglio così, perché chi suonerà il campanello sarà inequivocabilmente lei, niente confusioni e niente errori e scambi di persone e figuracce.
Il sole è sceso e il cielo si è patinato di buio, lentamente. Sono nervoso, non so come vestirmi e come riceverla. Ho messo io in moto quest’incontro ma spero che sia lei a gestirlo. Il suono sgradevole del campanello rompe i miei pensieri. Oltre la porta c’è lei. Respiro profondamente per dare aria a tutti i polmoni e apro. Appena vedo la sua faccia, mi rendo conto che me la ricordavo in ogni piega della pelle, in ogni dettaglio, che l’avrei riconosciuta tra mille. Il pericolo di scambiarla per un’altra non era mai esistito, era solo una forma di difesa, un trucco del mio cervello per costringermi a scappare, a non affrontare la responsabilità di quella chiamata, della situazione che avevo creato.
Entra. Ci salutiamo. Si siede e decidiamo subito, in silenzio, di finire alla svelta la bottiglia di vino che ha portato per vedere se qualcosa tra noi si sblocca, se riusciamo ad andare al di là delle parole cortesi e innocue che ci stiamo scambiando e che non riescono a ricostruire quella comunanza lasciata laggiù lontana, in quella notte dove tutto era magia. Siamo, tutto sommato, due estranei che tentano di accendere un fuoco e di riscaldarsi assieme. Le bottiglie di vino diventano due. La cena salta. I vestiti spariscono. E solo allora, quando vedo la cicatrice che corre sul suo ventre, il mio corpo riconosce il suo e ne ricorda odori sapori e vibrazioni. Solo allora smettiamo di parlare e ci ritroviamo in quella notte. Invece di parlare, avremmo dovuto subito spogliarci e strofinare le nostre pelli, mischiare i capelli, annusarci e leccarci e se i nostri corpi avessero risposto allo stimolo era fatta, altrimenti non c’era niente da fare e avremmo fatto meglio a salutarci e ad andare ognuno per la propria strada.
Dopo un paio di giorni, mi ha chiamato e mi ha chiesto se poteva sistemarsi qui da me per un po’. La sua amica se ne andava e lei non poteva permettersi l’affitto da sola. Le ho spiegato che un “qui da me” non esisteva perché anch’io ero “qui da qualcuno”. Avevamo ancora un paio di settimane di tempo, prima del ritorno di Paul. Tutto qui. A lei andava bene. A me anche.
Passiamo le giornate con dolcezza ascoltando Chet Baker e Keith Jarrett, mentre io tento di riordinare i miei appunti di viaggio per vedere se hanno già l’ossatura di un libro o se devo invece rielaborarli e riscriverli o semplicemente gettarli via.
Mi sento a mio agio di fronte alla sua leggerezza, quella leggerezza che può avere solo una persona di vent’anni che non ha ancora venduto l’anima per un lavoro, una carriera, un successo, una donna o un uomo, per i soldi o per un figlio. Io, invece, l’anima l’ho fatta a pezzettini e li ho veduti uno ad uno, e ne avrei volute di più di anime da vendere, un bel pacco di anime per garantirmi un futuro con i fiocchi. Ho venduto quello che avevo da vendere, ho anche tentato di imbrogliare.
Lei è entusiasta e piena di vita, non pensa troppo a quello che accadrà e se accadrà. È convinta che tutto andrà per il meglio. Questa sua spontaneità riempie la casa di tenerezza, di quasi amore. Ha detto che anche la casa non sarà un problema, che troveremo un buco dove andare, una topaia dove stringerci. Ho bisogno di questa sua positività che l’età, in me, ha trasformato in vizio, in qualcosa di iperbolico, di marcio e di inutile. Due cuori e una capanna per me sono un’assurdità, perché so che nella capanna fa fatica a starci anche un cuore solo e che se ce ne sono due, finisce che uno mangia l’altro. So anche che dovrò trovarmi un lavoro e che, prima o poi, me ne andrò di nuovo da qui e da lei, da una vita che mi diventerà di nuovo stretta e mi costringerà a scappare.
Abbiamo svuotato il salotto e ci abbiamo sistemato i materassi, così adesso è la nostra stanza da letto e da giorno e di tutto il resto. Ho comperato una grande cartina dell’Australia da Kmart, e l’ho appesa al muro. Rimaniamo ore di fronte a quel continente piatto a segnare con colori diversi percorsi di sogni e di viaggi, a cercare il posto più adatto dove potrei andare a nascondermi, a fare il clandestino, e appena ne troviamo uno, constatiamo che è troppo isolato e che ci morirei in pochi giorni.
Io le faccio vedere le strade che ho percorso e i luoghi che ho visto e parlo e parlo per ore di quella mia Australia e lei ascolta seduta sul materasso come una brava bambina ascolta le favole della mamma prima di addormentarsi. A volte si addormenta davvero e mi fa incazzare perché non ho mai pensato di essere tanto noioso.
Ci siamo spostati in salotto anche perché è la stanza più grande della casa, c’è più luce e c’è l’unica finestra che trattiene un pezzo di Oceano, che lo mette in cornice. Ed io, al mattino, mi sveglio e sento l’odore di quel mare profondo e vibrante, sento il suo respiro e mi sento di nuovo sulla mia isola di sabbia, e galleggio in quella sensazione di pace assoluta che riempie il momento in cui sei già sveglio ma i pensieri non hanno ancora cominciato a fare casino, a trascinarti verso il delirio della tua esistenza. Faccio di tutto per prolungare quella sensazione ma questo mio sforzo la dirada e la dissolve. Poi mi alzo, mentre lei ancora dorme, vado alla finestra e lo vedo, il mare, rotolare su se stesso, laggiù. Seguo con gli occhi il profilo della costa e cerco con attenzione il punto migliore, quello più calmo, protetto, il posto dove andrò, tra qualche tempo, ad appoggiare le mie nuove barchette di carta cariche di sogni e di domande, prima di ripartire. Lo faccio ogni giorno, ne ho bisogno. Devo sapere che quello spazio tra le rocce, quello mio, è sempre lì a disposizione. E solo quando lo ritrovo, solo quando ci casco dentro con gli occhi, posso girarmi verso il mondo, e sorridere.