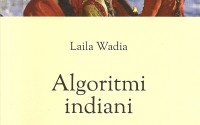Bob Dylan premio Nobel. Perché no?
Il Ponte rosso N° 18 | ottobre 2016 | poesia | Renzo Stefano Crivelli
di Renzo Stefano Crivelli
Per capire Bob Dylan occorre partire dal suo nome. Meglio dal suo nome artistico, perché in realtà si chiama Robert (Bob) Allyn Zimmerman; infatti la sua famiglia, di origine ucraina, nel 1905 fuggì da Odessa in seguito ai famigerati pogrom contro gli ebrei, e si trasferì a Hibbing, nel Minnesota, una zona mineraria dove la vita non è mai stata facile. Ma nel sangue di Robert, a citare la sua bibliografia, c’è anche sangue turco, russo e lituano. Dunque, a voler sommare i nomi dei suoi parenti più diretti, si potrebbe comporre un dizionario della diaspora di tutto rispetto. Ma lui, alla storia della musica contemporanea, e – ora – di quella della letteratura, appartiene con Bob Dylan. Perché?
Formatosi, negli anni sessanta, lui classe 1941, alla tradizione del blues, della musica country e del rock and roll, Bob amò e praticò la musica sin dall’adolescenza, fondando effimere band anche a livello scolastico. Per poi approdare definitivamente alla musica folk, lasciandosi alle spalle il furoreggiante rock and roll. Questo passaggio, che prelude al cambio di nome (a dire il vetro ne aveva cambiati già altri, ma questo sarebbe stato per sempre il suo marchio), sta alla base della sua scelta di essere “ben altro” da un semplice cantante alla moda. Una sorta di scelta “alta”, che segna in lui un inizio di consapevolezza artistica degna di traguardi ambiziosi. Intanto il passaggio all’uso di strumenti acustici, anziché quelli “elettrici” collegati ad un assordante amplificatore, gioca, in lui, a favore di una musicalità più “cauta”, in cui possano coesistere melodia e parola. Infatti, un’altra tappa importante della sua arte consiste nella rinuncia ai testi banali e solo urlati dei cantanti di rock, spesso utilizzati solo strumentalmente per supportare il clangore dei suoni.
Più tardi, a questo proposito, avrebbe spiegato molto bene le ragioni di questa abdicazione al rock, raccontando che si era reso conto della pochezza dei temi di quelle canzoni, ritenute evasive, troppo superficiali, accattivanti specie nell’ammiccare sonoramente al pubblico. Secondo lui i testi di quelle musiche erano una semplice evasione dalla durezza della vita. Non avevano nulla a che vedere con la realtà e la sofferenza umana. E la sua consapevolezza di questa “insufficienza” del testo (non quindi della musica) l’ha ben spiegata nella sua Biografia (si veda Bob Dylan: A Biography, di Bob Spitz ), quando ha detto che «c’è più realtà in un solo verso di una canzone folk di quanta non si trovi in tutto il repertorio del rock and roll». E da lì, oltre che dal suo nuovo e definitivo nome (ma su questo lascio ancora un po’ di suspence), occorre prendere l’avvio per cercare di capire perché Dylan può, a tutto diritto, appartenere alla categoria dei Premi Nobel in Letteratura.
Il cantautore ha frequentato l’Università del Minnesota. Risiedeva, infatti, nel quartiere studentesco di Dinkytown. Esordì professionalmente proprio lì agli inizi degli anni ’60 (suonava in un caffè a ridosso del campus). Tra altri studenti, cultori della musica e della letteratura, si avvicinò ad una visione poetica e filosofica “naturalistica”, aderendo ad una concezione vitalistica legata proprio alla natura, qualcosa che ben si discostava dai temi sdolcinati o falsamente populisti del rock di Elvis o di Paul Anka. Questa sua concezione “letteraria” della vita trova un importante corrispettivo in un grande poeta gallese, da pochi anni scomparso proprio in America, la cui parabola esistenziale è stata intensissima ma tragica, portandolo a morire – quasi involontario suicida – nel 1952 in un Hotel di New York. Il poeta si chiama Dylan Thomas, e ancora negli anni ’60 (e ’70) rappresenta la mitica figura dell’uomo che osa sfidare la natura, pur abbandonandosi ai suoi cicli drammatici e rigenerativi.
Dylan Thomas ci ha lasciato una poetica di grande forza espressiva (quasi surrealista), e la sua produzione in versi si fonda sull’immediatezza della comunicazione poetica, una sorta di canto (talvolta con i toni sermonali della tradizione presbiteriana cari al poeta gallese), che acquista una fondamentale dimensione orale. Lo stesso Dylan Thomas era un declamatore dei propri versi (aveva anche fatto l’attore in gioventù), e infiammava le platee americane (oltre che quelle europee) con veri e propri “concerti” vocali (sono gli anni dei grandi “poetry readings” davanti a folle di giovani). Era anche un alcolista, alimentando in questo modo la leggenda che si sarebbe ben presto trasferita sui beatnik (non più alcol ma anfetamine), generando i noti fenomeni di massa a favore dei grandi ideali e dei diritti umani. Di una overdose di whisky, peraltro, Thomas era morto, tra il compianto delle folle, specie americane.
Robert Zimmerman, dopo aver letto le poesie di Thomas, si infervora a tal punto da decidere di scegliere (dopo aver scartato quello di Robert Allyn) il nome di Robert Thomas, poi esemplificato in Bob (un diminutivo, invero, assai diffuso tra le band di quel tempo). Nasce così il personaggio artistico di Bob Dylan, un connubio fra un nome abbreviato da rock star e un nome per esteso del più noto poeta di quegli anni. E proprio nel 1961 esce il suo primo album, con una selezione di musiche folk, blues e gospel, unitamente a due testi suoi originali, intitolato per l’appunto Bob Dylan (una raccolta che non ha molto successo, ma che suggella ufficialmente il suo nuovo nome artistico, che verrà di lì a poco registrato ufficialmente all’anagrafe di New York). Da quel momento Dylan è il “poeta” che fa musica, piuttosto che il musicista che fa il poeta: e questa considerazione va sicuramente in direzione della sua “letterarietà” consapevole.
Ma un testo poetico, inteso come un testo di poesia, deve avere, oltre al requisito della musicalità (tant’è che in critica si parla di dimensione lirica) anche i contenuti adeguati, una prospettiva filosofica, un’urgenza esistenziale e civile. E i primi testi di Dylan rispondono subito a questi requisiti: anche sotto l’influenza della militanza di Woody Guthrie, egli affronta in musica e in versi problematiche come quella dello schiavismo (Blowin’ in the Wind) o della Guerra Fredda (la paura del nucleare che avrebbe trovato in Allen Ginsberg il cantore più alto della generazione beat) in A Hard Rain’s A Gonna Fall. E a cogliere questa tensione politica sarà proprio Joan Baez, il cui impegno civile è già fonte leggendaria, che lo vuole con sé sul palco (ma anche nella vita privata).
Certo, il collegamento fra Bob Dylan e Martin Luther King è essenziale per capire la sua tensione etica, trasferita sempre nei versi delle sue canzoni. Ma il riferimento letterario ci conduce ancora verso i poeti della Beat Generation, con cui condivise contenuti e dimensione “orale” della parola. Basti citare ancora Ginsberg, da cui ha mutuato la sovrapposizione immaginifica di paesaggio naturale (country) e di paesaggio urbano metaforico (l’alienazione della grande metropoli che cola tra le note e tra le righe dei testi). Infatti, se un giudizio stilistico sui testi “letterari” di Dylan può essere ben motivato, si può parlare di linguaggio surreale, spesso fra sogno e realtà, acceso e ambiguo, appuntito e straziante. Un esempio pratico lo si ha con la sua canzone forse più famosa, Mr. Tambourine Man, che, in linea con Dylan Thomas, è una ballata arcaica e moderna allo stesso tempo. Protagonista è un misterioso “vagabondo” (uno dei tanti senza tetto), che chiede ad un “tamburino” di suonare per lui fino a quando non arrivi l’alba. Chi sia questo tamburino non si sa, ma è indubbio che la tematica si innalzi a valore simbolico universale (è il tamburino della Guerra Civile, il ragazzo che muore quasi inconsapevole subendo il peso della Storia americana, il musicista che, come il “bardo” Dylan Thomas, canta il proprio popolo o il proprio clan). In questo testo è concentrato tutto il dolore degli esclusi e tutta la speranza di un’alba migliore nella prospettiva socio-politica americana. Ma non solo, e qui sta la sua ambiguità: è pure un’apertura alle anfetamine che fanno sognare i derelitti o i castaways. In slang di New York, infatti, il Tambourine è lo spacciatore, colui che vende speranze attraverso la marijuana.
La produzione artistica di Dylan è immensa (così come la lunghezza della sua vita) e variegata (non manca un filone ironico se non sarcastico, specie al tempo della caduta dei grandi ideali americani), ma è sicuramente possibile tracciare una sua evoluzione contenutistica, esattamente come si fa per un poeta. E tutto ciò è letteratura che, come tale, può benissimo essere premiata con un Nobel. Per concludere che oggi come ieri, come in un passato arcaico, in cui, attraverso l’uso della tradizione orale densa di parole “che soffiano nel vento” (blowing in the wind…) noi ci siamo sempre rispecchiati, sia come soggetti che oggetti letterari, da Omero fino ai nostri giorni. Forse qualcuno potrebbe obiettare un premio Nobel a Omero? Eppure è solo musica.