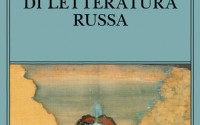Italiani in divisa austriaca
Fulvio Senardi | Il Ponte rosso N° 37 | Settembre-Ottobre 2018 | storia
Militari italiani tra patriottismo e lealismo nei confronti della duplice monarchia
di Fulvio Senardi
A volte mi chiedono perché, con diabolica perseveranza, continuo a occuparmi di libri, di saggistica anzi, quello scabroso settore della produzione editoriale che su molti giornali, quando appaiono le classifiche dei “top ten”, non viene nemmeno indicato. La speranza di far conoscere un libro e di conseguenza le tesi che propone ai cittadini del Paese meno colto d’Europa? Il desiderio di contribuire a diffondere delle visioni che spaccano la crosta del pregiudizio, quando oramai sappiamo – i politici vengono votati dal popolo, gli storici no, per far eco a una peregrina esternazione dell’attuale Ministro degli Interni – che il senso comune, anche in campo storico, è influenzato piuttosto dai borborigmi degli eletti che dalle riflessioni documentate e ponderate degli esperti? (Chi vive a Trieste sa di che cosa parlo, anche se temo che la situazione cittadina si ripeta pari pari all’ombra di molti dei mille campanili. Un po’ alla rinfusa: una sfilza di assessori, a destra e a sinistra, per i quali “cultura” non è, se va bene, che il termine che completa agri-, esternazioni amplificate dai Media che sanno di parole in libertà – il cavalier Renzo Codarin che si improvvisa storico della penisola istriana – , Enti ben noti per la faziosità delle posizioni – la Lega Nazionale – che assumono la gestione di musei dal forte valore simbolico e di grande rilievo pedagogico: il Museo del Risorgimento di Trieste, personalità di fresca nomina alla massima responsabilità della cultura regionale che proclamano il 2019 anno di Leonardo, minacciando di negare il finanziamento a chi, fra le associazioni del Nord-est, siano pure titolate, non si occupasse di Rinascimento: anche l’Associazione volontari della stazione-museo di Campo Marzio, per dire? Anche il Centro studi “Scipio Slataper” dunque?).
Ai margini di un incubo orwelliano (ricordate? Ignorance is strength, motto che regge le pratiche del “Ministero della verità”, anticipazione perfetta della fake-History con cui i politici alimentano la canea demagogica che fingono di condannare), un incubo cui solo l’endemico (e in questo caso provvidenziale) disordine italiano imprime una movenza piuttosto di farsa che di tragedia, ci si rifugia nella formula dell’ottimismo della volontà (ahimé, la adottò anche Craxi in casacca da maître nello spot elettorale del 1983). Ma forse è soltanto la scusa per un edonistico e disincantato piacere del fare. Che in questo caso alimenta la curiosità per un libro, ci apprestiamo a parlarne, che viene a colmare un imbarazzante vuoto nelle ricerche sugli austro-italiani nella fase del crepuscolo asburgico: Fra due divise – La Grande Guerra degli italiani d’Austria di Andrea Di Michele.
Già negli anni Novanta Lawrence Sondhaus autore di un saggio che continua ad essere, per il periodo che precede la Grande Guerra, opera di riferimento (In the Service of the Emperor – Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918, Boulder, East European Monograph, 1990, distributed by Columbia University Press, New York, pp. IX, 217, $ 28), lamentava la scarsità della bibliografia sull’argomento. E fino ad oggi poco era cambiato, anche perché Sondhaus aveva scelto di concentrarsi sul cinquantennio 1814-1866, “quando l’Austria ha governato gran parte dell’Italia del Nord e incorporato un gran numero di italiani nell’esercito e nella marina” (p. VI). Comunque l’importanza pionieristica del volume dell’americano è stata tale che, prima di venire alla Grande Guerra degli italiani d’Austria, è il caso di riassumerne alcune conclusioni, peraltro confermate, nella sua ottica più cronologicamente circoscritta, da Andrea Di Michele. Nella sua ampia prospettiva storica (solo l’ultimo dei sei capitoli è dedicato agli anni della Doppia Monarchia) Sondhaus si sente dunque di poter concludere che “esempi di ciò che gli storici italiani chiamerebbero patriottismo e gli austriaci tradimento sono state eccezioni, per quanto di grande visibilità, rispetto a un abituale buon adattamento, con punte perfino di lealtà tra i soldati italiani” inquadrati nell’esercito asburgico (ivi).
Detto questo, rassicuriamo: non si seguirà passo passo la complessa analisi dello storico statunitense, ma qualche punto merita, lo ripetiamo, di venir illuminato. In primo luogo il fatto che lungo tutto il Risorgimento le diserzioni di italofoni dai reggimenti austriaci rimasero entro limiti fisiologici, e divennero massicce solo dopo l’occupazione della Lombardia da parte dei franco-piemontesi, nella prospettiva del cambiamento di sovranità. A dimostrazione che l’appello patriottico diceva poco a soggetti reclutati in gran parte nelle campagne. Peraltro è stato ben documentato il valore dei reggimenti veneti a Königgrätz, come a smentire una certa diffidenza austriaca nei confronti degli italiani che vestivano la divisa dell’Impero. Così Sondhaus: “negli anni 1814-1848 l’Austria, pur senza vere ragioni, diffidò dei suoi soldati italiani, mentre ebbe piena fiducia, nello stesso periodo, nei suoi marinai di lingua italiana, che, relativamente almeno agli ufficiali, non la meritavano” (p. 81). La marina, dunque, per la quale va fatto un discorso differente: nata in un contesto di pretta italianità lungo la linea Repubblica veneta-Regno d’Italia-Impero d’Austria (italianità sotto il profilo linguistico ovviamente, nell’apoteosi – un tema che Sondhaus non tocca – del dialetto veneto in tutte le sue declinazioni) viene progressivamente “de-italianizzata” dopo l’incidente dei fratelli Bandiera. Nonostante ciò il ruolo dei marinai di lingua italiana nel corso delle vittoriose campagne navali del 1864 e del 1866 fu grande, anche se non in posizione di comando. Se sarebbe sbagliato – afferma Sondhaus – vedere in Lissa una vittoria “veneta”, si trattò certo di un trionfo della “marina multinazionale postquarantottesca”, “in cui la presenza italiana giocò una parte molto importante” (93), tanto è vero che – a scorno degli storici o degli pseudo-storici della giovane Repubblica di Croazia dove Lissa è ormai vista in luce patriottica – appena negli anni Ottanta la presenza croata nella marina militare austriaca supera quella italiana (p. 97), con una percentuale praticamente uguale di italiani e slavi del sud nel corpo ufficiali dal 1885 al 1907, come indica la tabella VII (dopo un periodo, 1802 -1848, di assoluta prevalenza italiana). Più vicino ai temi del libro di cui passeremo subito ad occuparci è l’ultimo capitolo, in parte dedicato alla Grande Guerra. Vi si registra una condizione complessiva di crescente sospetto da parte della autorità militari asburgiche nei confronti della popolazione di lingua italiana, tale da portare a veri e propri episodi di discriminazione, a fronte però di scarsissimi casi di diserzione o ammutinamento nelle forze armate (a Radkersburg e a Cattaro, nell’ultimo anno di guerra, fu decisiva la spinta ribellistica degli slavi del sud). Il timore dell’irredentismo, in special modo dopo il maggio del 1915, sfociò in forme di esasperata paranoia (“full scale paronoia”, p. 116): “la maggioranza degli italiani del Litorale e del Tirolo”, conclude Sondhaus, “si erano mostrati indifferenti alla sirena irredentista per quasi cinquant’anni, massimamente perché patriottismo e identità nazionali stringevano nodi complessi in queste regioni. Ma durante gli anni della guerra una diffusa diffidenza nel Litorale e l’internamento dei civili del Trentino furono abbastanza per lasciare un sapore amaro anche nella bocca del più convinto austrofilo e kaisetreu austro-italiano” (p. 116).
E qui mi pare Sondhaus anticipi un tema sul quale va riflettendo la più moderna storiografia, e a cui ha dato voce, con maggior chiarezza, un professore olandese attivo all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, Pieter Judson. Gli si devono le dense pagine di The Habsburg Empire. A new History (2016), volume che chiude una serie di ricerche sull’universo asburgico suggerendo che furono gli anni della guerra a dissipare un capitale ingente di reciproca fiducia tra autorità asburgiche e popoli soggetti, quando il potere fu consegnato ai militari, lo stato di diritto venne del tutto sospeso e l’intera società militarizzata con eccessi polizieschi ed inquisitoriali, rendendo difficili le condizioni di etnie non tedesche (i cechi, i ruteni, gli italiani, e siamo in Cisleithania, la parte più civile della doppia monarchia) considerate all’ingrosso (ed erroneamente), simpatizzanti del nemico. Per esse, nonostante secoli di fedeltà, liberarsi dell’aquila bicipite alla fine del 1918 fu come uscire da un incubo.
È in fondo la visione che, pur senza la lucidità d’analisi resa possibile solo dal senno di poi, propone Giani Stuparich nella prima edizione della Nazione czeca raccontando la tragica battuta d’arresto che la guerra scatenata dall’Austria impone al processo, che egli giudica in fieri attribuendogli buone possibilità di successo, di trasformazione della monarchia in uno stato dalle basi più solide e moderne: “con lo scatenare la guerra europea l’Austria impero ([…] l’Austria tradizionale del governo […] la crosta ammuffita […]) ha sorpassato l’Austria dei popoli”. Più che sorpassata, soffocata, con i risultati che sappiamo. Conferma questa lettura Fra due divise – La Grande Guerra degli italiani d’Austria, dove il discorso è articolato in quattro capitoli. Il primo fa il punto degli studi sugli italiani d’Austria con sintesi riuscita ma senza sprazzi di originalità (utile ripetizione però per coloro che ancora considerano l’Impero, dove già nel 1906 viene concesso il suffragio universale, una mazziniana “prigione dei popoli”), il secondo, In guerra per l’Austria, segue le vicende degli italiani in feld-grau, il terzo e il quarto, In Russia, tra Austria e Italia e Diventare italiani approfondisce un tema poco noto, ma che proprio a Trieste, grazie fra gli altri a Marina Rossi, è stato oggetto di indagini specifiche: il destino dei prigionieri austro-italiani in terra russa, uomini che la stato italiano cercò di guadagnare alla propria causa organizzando selezioni e trasferimenti. E da qui le stazioni di un’amara “anabasi” sempre sul filo del malinteso, con prigionieri pronti, per sfuggire alle impervie stagioni siberiane, ad accettare un’etichetta nazionale assai spesso inadeguata rispetto ad appartenenze prettamente locali, la regione, la valle, la città. “Gli italiani d’Austria”, spiega Di Michele, “pagarono il disinteresse e la disorganizzazione della autorità russe da una parte, ma anche le titubanze e le diffidenze nei loro confronti di quelle italiane dall’altra” (p. 131). Lo storico approfondisce con indagini più mirate e avvalendosi di una ricca bibliografia in tedesco (di solito preclusa agli studiosi italiani) e di ben ragionate incursioni negli Archivi di Stato di Vienna e di Roma, nell’Archivio diplomatico del MAE e nell’Ufficio storico dello Stato maggiore la percezione che di questi soldati si ebbe in Austria, dove vennero giudicati inaffidabili, creando così un mito duro a morire, funzionale tanto, in un primo tempo, alla dura discriminazione condotta nei loro confronti (e verso le comunità da cui provenivano) da parte delle autorità militari austriache (“si impose immediatamente lo stigma della codardia, dell’inaffidabilità e della predisposizione al tradimento che più che di dati e comportamenti reali si nutriva di scetticismi di antica data, oltre che di sedimentati pregiudizi circa l’inaffidabilità e la pigrizia dei popoli meridionali” – p. 95), quanto, dopo il crollo dell’Impero, all’affabulazione irredentista che (in Italia, in Cecoslovacchia, in Romania, ecc.) volle interpretare ogni atteggiamento di fastidio verso la guerra e ogni diserzione (atti, nella sostanza, per lo più privi di contenuto politico) come gesti di valore nazionale. A rendere inutile le proteste, che non mancarono, da parte di funzionari dello stato austriaco contro misure discriminatorie ritenute sbagliate e controproducenti giocò il fatto che l’Impero in armi optò per “l’istaurazione immediata di un regime ditattoriale di guerra senza paragoni con gli altri paesi coinvolti nel conflitto” (p. 61), con il risultato di un totale “asservimento del potere civile a quello militare” (p. 79). In conclusione: “essere italofoni significò per i soldati patire un pregiudizio negativo da parte delle autorità militari austro-ungariche” e “i maltrattamenti subiti e la marginalizzazione sofferta nell’esercito contribuirono a determinare l’allontanamento di molti di loro dall’idea di patria austriaca” (p. 224). Il volume di Di Michele, che raccomandiamo caldamente, si chiude sul paradosso di due destini, ben rappresentativo dei malintesi e delle mistificazioni che, anche sul piano storiografico, hanno accompagnato il tema di cui ci occupiamo: quello del goriziano Mondolfo, che, ancorché di fede irredentista, sceglie, prigioniero in Russia, di non passare dalla parte dell’Italia per non nuocere ai familiari rimasti a casa, e di Cislin, un contadino anch’egli originario del goriziano che, pur sentendosi patriota austriaco e fedele “al mio caro Impero”, opta per l’Italia, soprattutto per la delusione provata per la disistima espressa nei suoi confronti, in quanto italiano, dai compagni di prigionia (si noti l’amara ironia di ritrovare in lui tracce dell’esperienza di molti volontari giuliani nell’esercito italiano, di cui dà testimonianza Giani Stuparich in Guerra del ’15, ora sospettati di essere spie, ora disprezzati per aver spinto sulla via della guerra un Paese che voleva la pace).