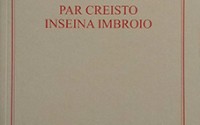Le Italie di Dante e la nostra
Francesco Carbone | Il Ponte rosso N° 58 | luglio 2020 | saggi
Percorrere, avendo Dante per Virgilio, l’Italia «con la sua bellezza e il suo sfacelo»
di Francesco Carbone
Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade.
(Dante, Convivio, III 5)
Il libro di Giulio Ferroni, L’Italia di Dante appare subito eccezionale e diverso rispetto a tutti gli altri volumi usciti di recente: quasi 1200 pagine che però, per merito dell’editore, danno un’impressione di leggerezza, di ariosità primaverile per la bella copertina di Tullio Pericoli, la scelta del bianco per le coste e il retro del volume e un carattere e un’interlinea che promettono una lettura non faticosa: buon lavoro sul paratesto fatto dall’editore, che ci aiuta a entrare fiduciosi in un diario di viaggio in Italia – tra il 2014 al 2106 – che può essere letto anche a brani, per regioni, magari per usarlo come guida per viaggi nostri: per esempio in Umbria, o a Viterbo e perfino in Sardegna.
Essendo un libro sull’Italia e su Dante, una questione sarà proprio dove collocare, nella libreria, il Viaggio di Ferroni: di quali libri sarà più amico (cfr. Libri: necessità di un ordine impossibile, Il Ponte rosso, n. 57)? Porlo tra i saggi su Dante, o accanto ad altri amati viaggi in Italia? Vicino ad Auerbach, Santagata, Pasquini, o a Ceronetti e Piovene? Non esiste ovviamente una risposta giusta, o sbagliata.
Ferroni ha realizzato un desiderio antico («Da tempo pensavo di fare un viaggio dantesco»): percorrere, avendo Dante per Virgilio, l’Italia «con la sua bellezza e il suo sfacelo». Bellezza e sfacelo ci dicono subito una questione essenziale, che torna in tutti i resoconti di viaggi recenti in Italia: di Guido Ceronetti i bellissimi e dantescamente feroci Un viaggio in Italia. 1981 – 1983, Einaudi 2004, e Per le strade della Vergine, Adelphi 2016, di Paolo Rumiz La leggenda dei monti naviganti (Feltrinelli 2007) e Appia (Feltrinelli 2016), di Marco Revelli Non ti riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia (Einaudi 2016): paesaggi quasi sempre feriti anche mortalmente dall’incuria, dal saccheggio edilizio, da opere grandi e minime sempre condonate, volute democraticamente da italiani posseduti, non meno che al tempo di Dante, dalla Lupa: simbolo, come si sa, dell’inguaribile avidità.
Come tanti racconti di viaggio, anche quello di Ferroni è allo stesso tempo una ricerca e una fuga, lungo un percorso che permette ogni sorta di divagazioni: sulla letteratura, i costumi di noi italiani, la nostra storia, il cibo, le strade, gli scrittori e i poeti di ieri e di oggi: un giro che da Roma va a Firenze e che a Firenze ritorna, per sfuggire «all’inessenzialità e all’inconsistenza di tanta letteratura d’oggi, alla sua subalternità al mercato, ai modelli mediatici; ed è un ritrovare le vere ragioni della grande letteratura […] sempre più trascurata dalla scuola».
Questa fuga nello spazio da una temperie culturale, una fuga che è dunque un ritorno a quanto di essenziale stiamo sempre di più perdendo, appare subito interessante: Thomas Mann, nella Montagna incantata, ci diceva già che ogni viaggio nello spazio è anche un viaggio nel tempo, come del resto sappiamo per prova un po’ tutti. Ma il tempo che cerca Ferroni, quello della «grande letteratura», è ancora una volta un tempo perduto.
Benché tra bellezza e sfacelo, il tono di Ferroni non è mai tragico, il suo viaggio trova in sé il senso cercato. Nell’ultima pagina, il libro stesso – come fu la Commedia per Dante – si rivela come «l’approdo di un lungo cammino», come una «nave» che ha trovato il suo «porto» (due metafore carissime allo stesso Dante), ribadendo così l’archetipo, come nell’Isola del tesoro di Stevenson, che il buon viaggio è sempre premio a sé stesso.
Come viaggiatore dantesco, naturalmente Ferroni ha alle spalle una lunga storia, e può essere utile qualche confronto. Il precedente più interessante è ancora oggi quello quasi leggendario di Alfred Bassermann (Orme di Dante in Italia, I ed. Heidelberg 1897, I ed. italiana nel 1902, ristampa anastatica di Arnaldo Forni Editore del 2006), che un paio di volte Ferroni cita. Bassermann (1856 – 1935) fu una figura non poco interessante: ricco e autodidatta, fulminato già giovanissimo da Dante, s’impegnò nell’impresa impossibile di una traduzione del poema in terzine incatenate: il metro inventato da Dante per la Commedia. Il compito lo prese per trent’anni, e non fu un successo. Molta più risonanza ebbe il resoconto, pubblicato a sue spese, dei suoi viaggi in Italia, arrivando «anche in luoghi impervi e a piedi» (W. Theodor Elwert, in Enciclopedia Dantesca, Treccani 1970) pur di vedere coi suoi occhi quanto Dante descriveva nel poema: e ancora oggi si può pensare che il suo resti «il miglior manuale per tanti pellegrinaggi danteschi» (Ibid.); certamente il primo studio della geografia della Commedia condotto non sui codici e nelle biblioteche ma andando di persona nei luoghi.
Bassermann, spesso animato da uno spirito rabdomantico e misticheggiante, finì da vecchio a decifrare la misteriosissima profezia del Veltro, il cane messianico che libererà il mondo dall’avidità (Inferno, I), con Adolf Hitler, e il DUX (Purgatorio, XXXIII) con Mussolini. Dopo di che, nel 1935, morì. Ciò non toglie che Orme sia ancora un libro godibile e non poco istruttivo, leggibile, come questo di Ferroni, anche in modo rapsodico e a seconda delle necessità.
Allo spirito visionario di Bassermann fece poi da controcanto la prudenza di Paolo Revelli, L’Italia nella Divina Commedia (Treves 1922), geografo di gran fama, che fu anche rettore dell’Università di Genova. Spesso Revelli è citato proprio per controbilanciare gli entusiasmi romantici del tedesco. Già prima, nel 1877, era nato il progetto, allora avveniristico, di un’edizione della Commedia illustrata con fotografie dei luoghi nominati da Dante: idea di Corrado Ricci che per questo si affidò a molti pionieri della fotografia, per lo più dilettanti: titolo definitivo La Divina Commedia illustrata nei luoghi e nelle persone: prima edizione Hoepli del 1896, terza e ultima del 1921 (valore al mercato antiquario attuale intorno ai 3.000 euro).
Per quanto opere ovviamente diverse, queste tanto più antiche condividono con il libro di Ferroni uno spirito appassionato, curioso, e una limpida vocazione pedagogica, tanto nei confronti di Dante, quanto per la conoscenza dell’Italia di oggi, Paese che troppi Italiani abitano come barbari accampati.
La scrittura è chiara, descrittiva, incline alla suggestione impressionista, in non pochi punti da buona guida turistica. Un esempio per tutti Brescia, dove «la piazza è dorata da un dolce sole meridiano: c’è animazione quasi soltanto sotto gli ombrelloni che proteggono i tavoli dei locali che si affacciano sul lato ovest, affollati soprattutto da gruppi di belle ragazze ciarliere». Di esempi simili se ne potrebbero fare moltissimi.
Come per i suoi predecessori, il Dante ritrovato da Ferroni resta quello del testo, senza che i luoghi possano aggiungere una qualche empatia ulteriore con il poema: troppo l’Italia è cambiata. Persino a Firenze «tutto sembra leggero e sfuggente, nel muoversi di turiste e turisti, nel dinoccolato sostare tre il Battistero e il Duomo di indifferenti fanciulle, quanto diverse, nei loro abbigliamenti, nei loro ridotti pantaloncini, nella loro femminilità così liberamente e agevolmente moderna e postmoderna, da quelle cantate nella dolce poesia d’amore. Impossibile cercare qualche segno o traccia, timida persistenza, di una Beatrice o di una Giovanna Primavera». Quell’impossibile lo si potrebbe provare già chiamando, come fa Ferroni, «fanciulle» le ragazze in shorts, e vedere come rispondono.
Questa impossibilità ribadisce un altro archetipo del viaggio in Italia: «In questa straordinaria riserva di caccia che per i viaggiatori stranieri è stata per oltre tre secoli l’Italia, in questo paradiso di delizie […], la presenza degli italiani risulta quasi sempre fastidiosa e ingombrante» (Attilio Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una tradizione culturale, il Mulino 2006). Non è persino un luogo comune quello di Flaiano, per cui l’Italia è il paese in cui si sono accampati gli italiani? E siamo ancora ad «amare l’Italia come una vecchia zia che deve lasciare l’eredità» (Vitaliano Brancati, Società lingua e letteratura d’Italia, Bompiani 1941). Un’eredità, si pensi a Venezia, sempre più allo stremo.
Come per Bassermann, i luoghi cercati da Ferroni non sono necessariamente quelli in cui Dante è passato, ma quelli che Dante cita. Data la penuria estrema di documenti (di Dante non abbiamo neppure una riga autografa), dove sia stato veramente Dante resta nella gran parte dei casi un mistero. Certo, leggiamo già nel Convivio che, cacciato da Firenze, «per le parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, pellegrino, quasi mendicando sono andato» (Conv., I, III, 4), e nel De vulgari eloquentia che sua patria ormai era il mondo: come per i pesci l’acqua («velut piscibus equor», I, VI, 3). Ma questo non ci dice nulla di dove poi effettivamente Dante sia stato: tanto meno negli anni seguenti a quelle due opere interrotte, e cioè negli anni, fino alla morte nel 1321, in cui ha scritto la Commedia.
Proprio perché troppo poco sappiamo, molto si è fantasticato, sia tra gli accademici che tra i dilettanti: visioni di Dante a Parigi, a Oxford, in Tirolo, e ovviamente seduto sullo scoglio sotto le falesie di Duino. Esiste una particolare e immedicabile follia provocata in tanti dalla lettura di Dante, della quale ci si può render conto leggendo L’idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante (Bompiani 1989). Né si può negare che Dante stesso non sapesse i rischi in cui incorrono i lettori naïf: «O voi che siete in piccioletta barca (…) / non vi mettete in pelago, ché forse, / perdendo me, rimarreste smarriti» (Paradiso, II).
Sul profluvio di enigmi lasciati da Dante, prendiamo il caso di Pola, citata nel IX canto dell’Inferno, come Arles in Provenza, per la presenza di una necropoli romana, fatta di sepolcri sparsi e dai coperchi spesso divelti. Arles e Pola servirono al poeta per dirci come gli apparve, subito oltre le mura di Dite, il girone degli epicurei: tombe piene di fuoco in cui gli atei, avendo creduto l’anima morta con il corpo, per contrappasso rimarranno rinserrati a bruciare in eterno.
Ferroni attraversa il Tagliamento, consapevole che forse Dante non andò mai oltre quel fiume, tanto meno arrivando a farsi gelare il viso da quei «venti schiavi» (Purg. XXX, 87) che noi chiamiamo Bora. Viene quindi a Trieste: si potrebbe dire per andare dalla via Dante di Trieste alla piazza Dante di Pola. A differenza che del cimitero di Arles (Alyscamps), di quello di Pola non restava traccia già dal XV secolo perché gli abitanti, malgrado i divieti delle autorità cittadine, rubarono i sarcofagi di pietra per usarli per le loro costruzioni: accadde anche a Roma al Colosseo. Di Trieste Ferroni ci lascia impressioni un po’ sorprendenti, come quella di piazza Unità, che «proietta verso una sorta di cordialità mediterranea, non senza una un po’ corrucciata ritrosia adriatica, la sua ambiziosa monumentalità dei tempi asburgici», concetto che si fa un po’ fatica ad afferrare; mentre è certo che il campo di concentramento di San Sabba non fu un «campo di sterminio», almeno se si tiene presente il significato di quel termine in opere essenziali come per esempio Raul Hilberg, Lo sterminio degli Ebrei in Europa (Einaudi 1999).
Che Dante fosse stato a Pola, scrisse l’entusiasta Bassermann, «ce lo dicono i suoi versi». Chissà. Nei commenti moderni della Commedia, si può leggere tutto e il suo contrario: che «per raffigurare l’inferno, Dante si rifà di norma a paesaggi ben conosciuti, tanto più dove l’invenzione è più strana e incredibile, in modo da renderla veridica e persuasiva» (Anna Maria Chiavacci Leonardi, Inferno, Mondadori 1991), il che rafforzerebbe l’impressione di Bassermann; ma anche che «il paragone con i cimiteri romani della Provenza e dell’Istria costituisce il fantastico retroterra mondano di una immagine monumentale e quasi cosmica» (Pasquini-Quaglio, Commedia, Garzanti 2004), il che, come pensava anche Giorgio Petrocchi, sposa l’idea che nella geografia di Dante molte «determinazioni o comparazioni geografiche [sono] guidate dal dono della fantasia» (Vita di Dante, Laterza 2008).
Per dire quanta fantasia permetta la scienza ermeneutica, vale la pena ricordare, sempre su Pola e Arles, la nota un po’ sorprendente di Robert Hollander, allievo di Charles Singleton (per Eugenio Montale «l’americano che ci spiegò Dante»), il quale in un’edizione per altro non poco pregevole e fittissima di note della Commedia, vede Dante, tra gli avelli pieni di fuoco degli epicurei, «non diversamente da quanto fatto fin qui, [in] un atteggiamento da turista» (Inferno, Holschki 2011). Il che forse americanizza troppo Dante, riducendo il pellegrino appunto a turista malgrado i traumi di Francesca che lo fa svenire¸ della rivelazione, nel canto seguente, che quelli che i migliori uomini di Firenze «son tra l’anime più nere», e, soprattutto, proprio nel IX canto, della scoperta di Virgilio impotente, incapace di aprire le porte di Dite.
Sono questioni che giustamente Ferroni sfiora appena. Perché appunto quello che conta è il libro, rispetto al quale l’autore non è che un mezzo. Dove sia stato Dante è di gran lunga meno importante di dove sia arrivata la Commedia. E proprio in Friuli vi fu una diffusione importante dei manoscritti del poema, di gran lunga i più diffusi, del Medioevo (circa ottocento): codici essenziali come il Fontanini, adesso alla Guarneriana di San Daniele del Friuli, il Bartoliniano e il Codice Florio a Udine (e su questo vedi Ermes Dorigo, I codici della Divina Commedia in Friuli in “Dante Studies”, 2010 e anche di Baccio Ziliotto Dante e la Venezia Giulia, Cappelli 1948).
Giulio Ferroni
L’Italia di Dante
La nave di Teseo, Milano 2019
- 1126, euro 30,00