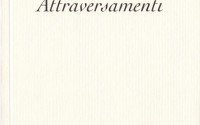Machiavelli e i sonnambuli
Francesco Carbone | giugno 2019 | Il Ponte rosso N° 46 | saggi
Le possibili sorti dell’Europa attuale trovano uno specchio inquietante nella storia italiana vissuta, descritta e in buona parte compresa da Machiavelli e Guicciardini
di Francesco Carbone
«…camminarono verso il pericolo
con passi guardinghi e calcolati.»
Christopher Clarck, I sonnambuli)
Thomas Stearns Eliot percepiva tutti i libri come pagine di un volume solo. In questa bibbia virtuale, i libri si rimandano gli uni agli altri, si nutrono a vicenda e creano costellazioni variabili per oroscopi a volte del tutto precisi: raro caso, a saperne approfittare, di comunismo felice.
Accade così di leggere due saggi importanti su Niccolò Machiavelli (Machiavelli e l’Italia di Alberto Asor Rosa, Einaudi 2019, e il bellissimo Nondimanco di Carlo Ginzburg, Adelphi 2018) assieme a libri recenti sul mondo attuale: Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo di Colin Crough (Laterza 2019), Come muoiono le democrazie di Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (Laterza 2018); e l’ultimo illuminante numero di Limes: Antieuropa, l’impero europeo dell’America (aprile 2019).
In questa miscela di passato e presente, Machiavelli è ancora di più un faro; e benché sia l’italiano più studiato al mondo, appare sempre non letto e non sfruttato abbastanza (che è poi il destino di ogni vero classico). Ma c’è qualcosa di più: perché le stesse possibili sorti dell’Europa attuale trovano uno specchio inquietante nella storia italiana vissuta, descritta e in buona parte compresa proprio da Machiavelli e Guicciardini: in quell’arco di tempo, dalla morte di Lorenzo il Magnifico (1492) al sacco di Roma (1527), in cui, con la complicità dei suoi stessi principi, l’Italia si lasciò invadere e spartire dalle nuove grandi potenze europee.
Quello che gli USA, la Russia e la Cina sono oggi per gli stati dell’Unione Europea, per i principati italiani furono la Francia, l’Impero e la Spagna. Come oggi, anche allora non esisteva una vera politica estera e militare comune: ai principi italiani, quello dei nuovi padroni d’Europa apparve un definirsi di forze vaghe, rispetto al quale sarebbe bastato piroettare tra alleanze occasionali e opportunistiche. Per «l’ignavia loro» (Il principe, cap. XXIV) s’illusero di poter ottenere grandi vantaggi con minimi sforzi: senza alcuna coscienza del peso vero degli eventi, improvvisando, non sapendo vedere oltre la punta del loro naso: «credo che ambuliamo tutti in tenebris, ma con le mani legate di dietro per non potere schifare le percosse» (F. Guicciardini, Lettera a Niccolò Machiavelli, 7 agosto 1525).
Il vincitore Carlo V fu incoronato imperatore dal papa sconfitto, Clemente VII, a Bologna nel 1530: cerimonia che della libertà d’Italia fu il funerale fastoso e definitivo. La Storia d’Italia di Guicciardini è la descrizione di quell’agonia: labirintica come il Furioso di Ariosto e gremita di piccoli potenti pazzi come il Giudizio di Michelangelo. Guicciardini e Machiavelli furono i soli ad avere una visione all’altezza di quanto stava accadendo: il paese più ricco e più colto d’Europa era stato incapace persino di concepire la necessità di federarsi e di darsi un esercito comune per impedire di farsi preda delle nuove grandi potenze.
Il sottotitolo del saggio di Asor Rosa è Resoconto di una disfatta, ed è necessario interrogarsi se si tratti di qualcosa di perfino più profondo della morte del Rinascimento. Asor Rosa scrive che lì dell’Italia finì «la storia, anzi la Storia»: si tratta di un momento di particolare empatia con il sentire di Machiavelli o c’è qualcosa di più?
Leggiamo in altri tra i migliori lettori di Machiavelli: nella sua opera c’è la testimonianza del «destino (sottolineatura nostra) di un popolo e di una cultura», destino in cui ancora siamo (M. Martelli, Firenze, Letteratura Einaudi, 1989). Gennaro Sasso, ha scritto che quel destino è giunto a un punto di tale cronicità «che pochi sembrano accorgersene»: rattrappiti in «un lungo sonno» dal quale non pare possibile svegliarsi (A. Gnoli, G, Sasso, I corrotti e gli inetti. Conversazioni su Machiavelli, Bompiani 2013).
Quest’idea del sonno come simbolo di un’ignoranza pressoché assoluta va preso sul serio. Rimanda ad esempio al titolo del già classico I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra di Christopher Clarck (Laterza, 2013): con ricchezza di documentazione lì si mostra come il Continente fu portato all’autodistruzione da politici e militari «apparentemente del tutto immuni da dubbi sul proprio operato». Il punto per noi interessante è che il contesto in cui Clarck ha scritto il suo saggio era la crisi economica dell’Eurozona del 2011-2012, evento a sua volta «di sconcertante complessità», i cui responsabili agirono anche loro incoscienti di quanto stessero facendo: «da questo punto di vista, gli uomini del 1914 sono nostri contemporanei», come lo sono i principi italiani del Cinquecento. Jacques Lacan ci aiuterebbe a capire che quello stato di inviolabile sonnambulismo è il modo in cui gli uomini esorcizzano una Realtà smisurata e avversa: tale che appare preferibile farsene distruggere, ma sognando, che capirla.
Nel 1513, Machiavelli in esilio scrisse Il principe per nessuno: il nipote del Magnifico, a cui era stato offerto, gli dedicò meno tempo che ai suoi nuovi cani da caccia. Venticinque anni dopo, Guicciardini scrisse di getto, nel tempo che gli rimaneva da vivere (1537-40), la Storia d’Italia: la scrisse da sconfitto, ormai lontano da quel potere sonnambulo – la Chiesa – che aveva servito con incarichi tra i più alti (cfr. le due biografie di Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, Castelvecchi 2014, e Vita di Francesco Guicciardini, Rusconi 1982). Ma l’opera di Guicciardini è a disastro avvenuto; quella di Machiavelli, che morì mentre i lanzichenecchi erano a Roma (1527), si dà tutta in un tempo in cui era ancora legittimo sperare. La sorte del suo Principe è dunque paradossale: «difficile trovare nella storia un esempio pensante di più radicale impossibilità del sapere di trasformarsi in azione» (Asor Rosa), quando proprio come «breviario per l’azione» (Giorgio Inglese, Introduzione a Il principe, Einaudi 2013), e per un’azione urgente, era stato concepito.
Paragonare l’Europa attuale con quell’Italia è certo un’operazione rischiosa, «ma una ricerca che eviti il rischio finirà col risultare innocua, cioè irrilevante» (Carlo Ginzburg, Nondimanco, Adelphi 2018). In ogni caso, non è mai vero che il passato stia da una parte e il presente dall’altra: pensassimo così, il passato si vendicherebbe diventando il nostro inconscio e ci userebbe per i suoi fini, che così degradati non sono mai buoni. È «una miope scienza storica» quella che si spezzetta in epoche studiate come se fossero compartimenti stagni (Ernst Robert Curtius, Letteratura europea e Medioevo latino, La Nuova Italia, 1993).
E dunque azzardiamo ancora: degli europei di oggi gli italiani del Rinascimento appaiono un’anticipazione: fu «il primo popolo che imparò ad essere egoista» (J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, Sansoni 1996): ricchi, istruiti, «molli ed effeminati per lunga pace» (Il principe, cap. VI), incapaci di guerra, per nulla interessati a un’effettiva unificazione, dati i sacrifici che questa imporrebbe adesso in vista di vantaggi che si vedrebbero appena domani, posseduti dalla naturale «incredulità degli uomini, i quali non credono in verità le cose nuove, se non ne veggono nata esperienza ferma» (ibid.). È più o meno il modo in cui da tempo ci vedono gli americani.
Non solo per l’ostacolo ineliminabile della mancanza di una lingua comune, l’unità europea è un progetto impossibile, un vagheggiamento e un velamento propagandistico di una realtà ben diversa. Questo perché, come l’Italia del Cinquecento, anche l’Europa ha la sua catastrofe alle spalle: l’equivalente fu l’insieme di fatti che, tra il 1914 e il 1945, portò al suicidio della parte ricca del continente come cuore del potere mondiale. La Grande Guerra fece iniziare il predominio degli USA in Europa (Geminello Alvi, Il secolo americano, Adelphi 1996). L’isolazionismo USA tra le due guerre fu l’errore – mai più ripetuto – di lasciare per l’ultima volta l’Europa padrona delle sue dinamiche. Seguirono il nazismo e la nuova guerra che ci lasciò in macerie e definitivamente incapaci di una vera soggettività politica: «nella storia del mondo, non si era mai o quasi mai assistito alla decadenza di una civiltà nel giro di un così ristretto numero di anni» (Ugo La Malfa, Introduzione a J.-J, Servan-Schreiber, La sfida americana, Etas Kompass 1968). Salvati da Hitler da russi e americani, gli europei si ritrovarono spartiti tra i due vincitori senza poter fiatare sulla sorte di Polonia, Grecia, Italia, Germania, ecc.: paesi che, con la Cortina di ferro, «fu licito pigliare col gesso» (Il principe, cap. XII).
A Ovest, di questo rapporto di forze la NATO fu la cristallizzazione: la storia dell’Europa al di qua della Cortina di ferro sta tutta nella formula «To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down» di Lord Ismay, primo segretario generale dell’Alleanza Atlantica e, durante la guerra, braccio destro di Churchill. Sarebbe ingenuo, agli antipodi della «realtà effettuale della cosa» (Il principe, cap. XV), illudersi su un’effettiva libertà dell’Europa dalla potenza imperiale americana. La NATO, «Antieuropa realizzata» (Limes, aprile 2019), nacque non solo per contrastare l’URSS, ma per impedire che nel nostro continente emergesse una potenza – Machiavelli direbbe un principe – capace di catalizzare e federare attorno a sé gli altri stati: principe che avrebbe potuto essere solo la Germania.
Tutto questo fu, per chi doveva e deve sapere, sempre chiarissimo: nella riunione segreta del 3 aprile del 1949, il giorno prima della firma del Patto Atlantico, Truman informò che, in caso di conflitto con l’URSS, gli USA avrebbero potuto usare la bomba atomica contro gli alleati dell’Europa occidentale se questa fosse stata occupata dall’Armata Rossa. Con la fine della Guerra Fredda, lo stesso allargamento dell’Unione Europea a Est obbedì a interessi molto più americani che nostri, essendo il vero scopo inglobare nello schieramento NATO gli ex paesi comunisti.
Certo è stato un bene di cui stiamo perdendo la percezione aver definito crescenti spazi di mercato comune, con una moneta e con l’unico parlamento transnazionale del mondo, ma al prezzo di rimanere un soggetto politico irrilevante: «qual è il numero di telefono dell’Europa?» domandò sarcastico Kissinger; una battuta molto simile a quella di Ludovico il Moro all’ambasciatore di Venezia: «Voi mi parlate dell’Italia, e io non la vidi mai in viso».
Il parlamento europeo appena rieletto potrà legiferare su molte cose, ma non potrà neppure immaginare – né c’è chi lo desideri davvero – di farsi soggetto politico unito per porsi sullo stesso piano di USA, Russia e Cina. Resterà un parlamento di nazioni che «stanno semplicemente in su la volontà e fortuna di chi gli ha fatti grandi» (Il principe, cap. VII). Il «goffo pigmeo» (Colin Crough, Postdemocrazia, Laterza 2013) è tale non solo rispetto alle grandi potenze ma ai signori mondiali del mercato globalizzato, signori per i quali la democrazia non è mai un fine ma uno dei mezzi possibili e che la politica, in qualunque modo si travesta, proteggerà «in ogni caso» (Colon Crough, Il potere dei giganti, Laterza 2013). I ceti politici al momento dominanti fanno la loro parte convincendo le masse che il nemico è sempre fuori e in basso, mai in alto: nel nuovo sonnambulismo, la democrazia come l’Europa si svuota di linfa vitale: possiamo «impedire che muoia dall’interno» (Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Come muoiono le democrazie)?