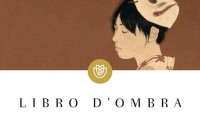Reliquie di tenerezza
Alberto Brambilla | aprile 2023 | Il Ponterosso N°91 | mostre
Incontro oggi, per la prima volta, i lavori
di Giulio Calegari, che espone alla Fondazione
Bandera di Busto Arsizio La mostra è intitolata
Fugaci umane tracce, è a cura di Cristina
Moregola, ed è introdotta da un illuminante
testo critico di Lorella Giudici. Se non
temessi di cadere nel sentimentalismo, direi
che la cifra riassuntiva del mio colloquio con
queste singolari opere risieda nella parola tenerezza.
L’etimologia latina, tenerum, ci distoglie
dalla retorica e ci riconduce sulla retta
via interpretativa, cioè a qualcosa di sensibile
al tatto, che si vorrebbe accarezzare e custodire
con la venerazione che si riserva alle
reliquie incontrate sulla via del destino. L’ultimo
verbo, custodire – che si distingue dal
più freddo conservare – ben si attaglia alle
opere di piccolo formato proposte in galleria
dal poliedrico artista, un po’ etno-archeologo
e paletnologo, un po’ filosofo e altro ancora.
Custodire con cura e accarezzare si diceva,
ma quali cose? Come accade spesso, le parole
qui non servono a spiegare perché le reliquie
che Calegari in-teca (cioè letteralmente
custodisce in un apposito contenitore, una
teca appunto) sono molte e le più svariate. E
seppure circoscritte sono visibili, e invitano
come si diceva ad un rapporto tattile, con i
polpastrelli e lo sguardo in primis, ma anche
attivando gli altri sensi.
La miniere da cui sono estratte, anzi,
raccolte, sono infatti illimitate, sia nello
Spazio che nel Tempo. Sono colori naturali,
secrezioni di piante, profumi antichi, relitti
di gasteropodi, tracce di umidità e misteriosi
segni della presenza umana, che però
qui non è mai violenta e soprafattrice. Essi
si dispongono come pagine e capitoli di un
Journal de voyage che in effetti testimonia
delle esperienze e delle spedizioni dell’autore
nelle più remote parti del mondo; ma è un
diario aperto che esige di essere letto e interpretato.
Il gioco sottile a cui siamo invitati a
partecipare si svolge in forma quasi di danza
rituale è tra Scienza e Poesia. Da un lato c’è
infatti in Calegari una palese volontà di catalogazione,
cioè di ordinare e dare un nome
alle cose, secondo le regole apparenti della
nomenclatura scientifica. Come ho sperimentato
di persona durante una visita con
l’artista, egli è infatti in grado di nominare,
descrivere e spiegare ogni sfaccettatura delle
pietre lavorate, ogni luogo d’origine dei
lacerti, dei semi e degli umori esposti all’attenzione
dei visitatori, Dall’altro versante,
non è però meno intenso un sentimento di
stupore infantile mai sopito, di una partecipazione
amorosa, di riunione spirituale e
fisica con tali reperti che intessono relazioni
insospettabili e rinviano alla Grande Madre;
considerata da Calegari affettuosamente, ora
come un bimbo in fasce, ora come un vecchio
morente. A ciò soccorrono appunto le
lievi tracce umane, i disegni, e scritture poetiche
che si inseriscono nelle tavole preparate;
anzi, si incontrano e si sposano con esse
grazie all’ausilio dei tratti, dei rapporti che
ricordano le Myricae di Pascoli (si pensi alla
poetica del fanciullino) e soprattutto i versi
di Camillo Sbarbaro, il quale non a caso
fu lichenologo di fama internazionale. Così
i grafici delle cartelle mediche e le cifre e
le mappe esposte da Calegari possono specchiarsi
nell’acqua lustrale millenaria, dialogare
con le piante medicinali (per il corpo
e per l’anima) estinte e ascoltare i richiami
delle ninfe. Impossibile stare a guardare senza
godere della nostalgia di quell’incanto.