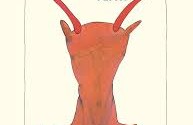Uno spazio vuoto contro il teatro mortale
agosto 2022 | Il Ponte rosso N°83 | Stefano Crisafulli | teatro
Riflessioni sull’opera di Peter Brook
di Stefano Crisafulli
«Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio. Un uomo lo attraversa e un altro lo osserva: è sufficiente a dare inizio a un’azione teatrale». Con queste parole Peter Brook, il grande regista teatrale, direttore del Théatre des Bouffes du Nord di Parigi, morto il 2 luglio 2022, iniziava un libro, Lo spazio vuoto (Bulzoni, 1968) che ha segnato chiunque si occupi di teatro. Erano anni di fermento culturale e sociale e l’ambiente teatrale doveva fare i conti con i tentativi di innovazione portati avanti dalle avanguardie teatrali e con una crisi conclamata del teatro classico tradizionale, quello che Brook definiva il ‘teatro mortale’. Apparvero, all’epoca, molti modi per declinare questi tentativi di innovazione, che Brook non manca di citare nel libro, come, ad esempio, il teatro povero di Grotowski e il Living Theatre di Judith Malina e Julian Beck, cercando di ritrovare nelle loro sperimentazioni quegli aspetti di vicinanza e, allo stesso tempo, di differenza con la propria idea di teatro. Un’apertura, dunque, alla varietà delle espressioni artistiche, senza preconcetti, perché, come aveva scritto in un’altra opera, Il punto in movimento (1987, Ubulibri): «Non ho mai creduto in un’unica verità, né in quella mia né in quella degli altri; sono convinto che tutte le scuole, tutte le teorie possono essere utili in un dato luogo e in una data epoca; ma ho scoperto che è possibile vivere soltanto se si ha un’ardente e assoluta identificazione con un punto di vista. A mano a mano che il tempo passa, che noi cambiamo, che il mondo cambia, tuttavia, gli obiettivi si modificano e il punto di vista muta».
Che cos’è, dunque, il ‘teatro mortale’ e come si possono evitare le sue trappole? è quello che, sostanzialmente, si ripete. Ripete ciò che sa, che ha già acquisito e che funziona, anche se suona falso, abituando, tra l’altro il pubblico a percepirlo come l’unico teatro possibile (e, del resto, «ogni pubblico ha il teatro che si merita»). Il teatro mortale può colpire indifferentemente Brecht, Molière o Shakespeare, anzi, proprio a quest’ultimo «si adatta benissimo», quando ad esempio le sue opere vengono interpretate da attori corretti, con i costumi d’ordinanza e la musica giusta: eppure il pubblico si annoia. Brook non si riferisce solo al teatro della tradizione, ma anche a quel teatro di ricerca che continua a ripetere i suoi stilemi anche se i tempi sono cambiati. Perché «nel teatro – afferma– ogni forma, una volta nata, è mortale; deve quindi essere concepita di nuovo affinché possa contenere i segni di tutte le influenze che la circondano. In questo senso il teatro è relatività». Per evitare di cadere nel teatro mortale sarebbe bastato assistere al Re Lear che lo stesso Brook ha messo in scena nel 1962 e che costituì un vero e proprio spartiacque: la sfida venne vinta dopo aver eliminato tutti gli orpelli non necessari, come le scenografie o le luci ‘giuste’, per arrivare al contatto diretto dell’attore con lo spettatore che, come abbiamo visto in precedenza, è, per il regista inglese, l’essenza stessa del teatro. Un teatro vitale, gioioso, che ricostruisca il rapporto col pubblico non in termini paternalistici («io so quel che va bene per te»), ma in modo che gli spettatori ne avvertano la necessità intrinseca, risvegliando la loro fame d’arte e di cultura. Un teatro che sia la porta per accedere a una verità invisibile: qui vi è anche l’influenza, pienamente ammessa dall’autore, di Artaud e del suo teatro della crudeltà, anche se poi ciò che preme di più a Brook è l’importanza data al gesto e al corpo e un ritorno a una certa forma di ritualità che, nel mondo occidentale, si è perduta. Stando attenti, però, a non imitare soltanto le forme esteriori di rituali già esistiti, precipitando di nuovo nel rischio di un teatro mortale. Qual è il ruolo del regista in un teatro di questo tipo? Egli è «una guida nella notte», che deve sempre fare i conti con il vuoto iniziale e imparare via via che lo spettacolo viene costruito, ponendosi domande anche scomode: «Sono necessari i costumi? È necessaria la musica?». Mentre un regista diventa ‘mortale’ se ‘non mette mai in crisi i riflessi condizionati» presenti nel teatro. Ma cos’è, allora, il teatro? È uno spazio creativo e giocoso che, secondo Brook, rischia di perdere la propria funzione in una società che separa la cultura dalla vita, come se l’arte dovesse essere migliore della vita e quindi sfarzosa in termini economici, per poter sedurre il pubblico. La verità, nel teatro, è invece sempre in movimento: non ripetizione ma rappresentazione.
Peter Brook
Regista teatrale, cinematografico e televisivo inglese (Londra, 21 marzo 1925 – Parigi, 2 luglio 2022), figlio di un immigrato lettone espatriato nel Regno unito per motivi politici, laureato in Scienze alla Sorbona come la moglie, visse gli anni della formazione all’interno di una famiglia dove erano vivi gli interessi per la scienza e la cultura, che favorirono gli interessi letterari del figlio attraverso letture e viaggi nelle principali capitali europee. Si laureò a Oxford ed esordì giovanissimo nella regia teatrale con il Doctor Faustus di Marlowe (1943), imponendosi ben presto come acuto interprete del teatro di Shakespeare (Pene d’amor perdute, 1946; Re Lear, 1962; La tempesta, 1968; Sogno di una notte di mezza estate, 1970; Antonio e Cleopatra, 1978), mentre la sua lettura del Tito Andronico del 1955 lo rese celebre a livello europeo. Fu direttore della London’s Royal Opera House (1947-50) e dal 1962 della Royal Shakespeare Company. I suoi interessi esondarono al teatro elisabettiano, affiancando al repertorio tradizionale opere moderne e lavori sperimentali, recependo in particolare le indicazioni del “teatro della crudeltà” di Artaud (Les paravents di J. Genet; 1963, Marat-Sade, 1964, e L’istruttoria, 1965, di P. Weiss; US, 1966). Nel 1970 ha fondato a Parigi il Centre international de création théâtrale, dove, sotto l’influenza di J. Grotowski e del Living Theatre di J. Beck, sono state sperimentate le possibili applicazioni teatrali di un linguaggio non significante, improvvisato e massimamente gestualizzato (Orghast, 1971; Les Iks, 1975; Ubu roi, 1977; Mahābhārata, 1985; Woza Albert, 1989, nuovo allestimento della Tempesta, 1990; Who is there, 1995; Sizwe Banzi est mort, 2006). Tra i suoi film: Moderato cantabile (1960); Marat-Sade (1966); King Lear (1970, per la televisione); La tragédie de Carmen (1983, per la televisione); The tragedy of Hamlet (2002, per la televisione). Tra i suoi scritti: The empty space (1968; trad. it. 1968); The shifting point. 1946-1987 (1987; trad. it. 1988); The open door (1993; trad. it. 1994); Oublier le temps (2003). Nel 1998 fu anche pubblicata la sua autobiografia Threads of Time: Recollections,, edita in italiano nel 2001 con il titolo I fili del tempo; Memorie di una vita, (Feltrinelli).
Peter Brook