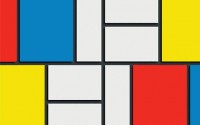Vivian Maier, una vita nell’ombra!
fotografia | Il Ponte rosso N° 47 | luglio 2019 | Paolo Cartagine
In una mostra triestina il punto sull’autrice statunitense e sui suoi autoritratti in formato 6×6
di Paolo Cartagine
Se, nel 2007 a Chicago, l’immobiliarista statunitense John Maloof non fosse stato incuriosito da un nutrito corpus di materiali fotografici (pellicole, stampe, diapositive) che acquistò per 380 dollari e se, attratto dal contenuto, non avesse poi continuato le sue ricerche assieme ad altri studiosi, il mondo non avrebbe probabilmente mai conosciuto Vivian Maier.
Nata a New York nel 1926, dagli anni ’50 era stata un’invisibile e riservata bambinaia della media borghesia a New York e Chicago, che da autodidatta si era dedicata quotidianamente alla fotografia, sua vera grande passione. Profondamente riservata, non pubblicò né fece vedere alcuna sua foto, e molte pellicole vennero sviluppate solo dopo la sua scomparsa. Una maniera silenziosa per definire la propria posizione nel mondo, confluita in un voluminoso archivio andato smembrato all’asta nel 2007 (senza indicazione dell’autrice/proprietaria), perché l’ormai anziana Maier non pagava più l’affitto del magazzino in cui lo aveva depositato.
Morì a Chicago 2009 dopo una lunga degenza in seguito a una caduta, senza sapere che le sue fotografie iniziavano a essere conosciute con interesse e consensi diffusi, tanto da venir oggi considerata un’autrice imprescindibile per la Storia della Fotografia.
Una personalità introversa e un carattere schivo oggi entrano in una biografia in divenire – seppur parzialmente romanzata dai mass-media, non scevra da talune dissonanze e con qualche contorno ancora da definire – dalla quale emergono atteggiamenti metodici e comportamenti complessi di un agire in posizione volutamente defilata e solitaria senza legami affettivi o sentimentali. Al contempo, la lettura di quotidiani, una curiosità per ciò che accadeva e interessi culturali precisi (nel ’52 al MoMA di New York aveva visitato Five French Photographers, fondamentale mostra di Brassaï, Bresson, Doisneau, Izis e Ronis) riempirono le sue giornate.
Non si contano le famiglie presso cui lavorò, talvolta anche per periodi piuttosto brevi e burrascosi (mentre in altre circostanze i ricordi furono positivi), intervallati da alcuni viaggi in Asia e in Europa con le sue macchine fotografiche: la Rolleiflex bi-ottica dal mirino a pozzetto acquistata nel ’52 e la più agile Leica nel ’70.
Le immagini della Maier ci raccontano con sguardo garbato, vivace, sensibile e penetrante gli Stati Uniti d’America della gente comune, osservata con empatia e mostrata con stile personale, lontano dalle mode, con una scrittura sobria e coinvolgente. Accanto a foto dei bambini che accudiva e portava a passeggio, la sua produzione pullula di significative immagini rapportabili alla street photography, una sommessa ma efficace ricerca sociologica ricca di aneddoti e spunti di riflessione sul vivere quotidiano e sull’importanza dell’ordinario.
Però la parte più sottilmente affascinante e misteriosa è costituita dai suoi inesauribili autoritratti in bianconero e a colori sui quali è incentrata (con taluni inediti per l’Italia) la Mostra The Self-Portrait and its Double, promossa dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione, fra gli altri, con John Maloof Collection, visitabile al Magazzino delle Idee a Trieste dal 6 luglio al 22 settembre 2019.
Un’occasione imperdibile per avvicinarsi ed entrare nei suoi appunti fotografici più interiori, personali e diretti, per interrogarsi e scavare in profondità su tanti quesiti concatenati che – nella stratificazione di senso propria delle immagini – travalicano la fotografia come atto di rappresentazione tecnica del mondo e dell’essere umano. Ma anche per cercare di individuare quel filo sottile che, in maniera ineludibile, connette la personalità dell’autore con la sua produzione espressiva, lungo la traccia di Freud quando sosteneva che “ogni azione umana ha sempre una motivazione, anche se spesso è inconscia”.
Se la fotografia è una finestra sul mondo dovuta alla presenza/assenza di un artefice che non appare, l’autoritratto è la maschera dell’universo autoriale.
Con la ripetuta e insistita produzione di autoritratti (l’ombra che si estende a terra, la figura intera o il volto riflessi negli specchi e nelle vetrine) la Maier genera un inestricabile cortocircuito “autrice – soggetto – oggetto – osservatrice di se stessa”, quasi a voler dimostrare la sostenibilità di esserci e di comprovare la propria identità.
Corpo e identità sono temi su cui l’uomo si interroga da sempre: tu cosa vedi in me?, come devo mostrarmi e cosa determina il mio valore agli occhi degli altri?, ho bisogno del giudizio della società?
È ragionevole ipotizzare che l’attenzione che non mai ha avuto – e la conseguente carenza d’amore già in un’infanzia difficile per l’abbandono del padre, con una madre scarsamente affettuosa – abbiano spinto la Maier a rinchiudersi e a cercare la via d’uscita nella raffigurazione del proprio doppio, una coesistenza della necessità di essere compresa per non sentirsi sola e la paura di aprirsi. Sintomo evidente quest’ultimo negli autoritratti perché, tranne rare eccezioni, non sorride e il suo sguardo non è diretto in macchina: Lei non ci guarda, è come se non esistessimo, si mostra ma si sottrae. Una doppia negazione che, per certi versi, richiama alla mente La lettera rubata di Poe, dimostrazione che l’occultamento ottimale è quello che non cela alcunché, e per questa ragione è più difficile percepire la realtà in quanto nulla è come appare.
L’autoritratto fotografico è una trasposizione tecnologica a densissima brevità, dato che un unico personaggio occupa l’intero spazio a cavallo della macchina fotografica dentro e fuori l’immagine, ma anche prima e dopo lo scatto. È al contempo desiderio di un qualcosa e la sua inafferrabilità, dislocazione dell’auto-fotografarsi verso la libertà di immaginare una vita differente per trovare un ruolo e ritagliarsi uno spazio, per lo meno a livello interiore.
Un racconto individuale della sua esistenza che la Maier ha inserito in un contesto spazio-tempo dove luoghi e ambientazione non sono secondari o trascurabili, messa in scena e narrazione reiterate con un gran numero di foto alla ricerca di se stessa, tutte costruite con estrema cura del dettaglio e mai meccanicamente ripetitive. Non l’esposizione delle circostanze ma direttamente il vissuto, un chiaroscuro psicologico da dipanare nell’accumulazione quasi quotidiana di immagini, realizzate non per l’esibizione, la condivisione o il mercato com’è poi avvenuto.
Uno strano destino per le foto che la Maier aveva concepito affinché rimanessero strettamente circoscritte, occultate, da non divulgare quasi fosse priva di importanza la particolarità della sua vita.
Perché scrivere senza lettori? Un quesito che innesca, pur con i dovuti distinguo, una prossimità con Emily Dickinson e Franz Kafka, accomunati nelle parole di John Donne: “Nessun essere umano è un’isola, ciascuno è un pezzo del continente e una parte dell’oceano”.