ALMA NEL VENTO DELL’EST
Il nuovo romanzo di Federica Manzon le conferma un posto nella letteratura di Trieste, come e più che una cittadinanza onoraria
di Walter Chiereghin

Quasi a contraddire il titolo del nuovo romanzo di Federica Manzon (Alma, Feltrinelli 2024), la figura di Alma non esaurisce in sé l’attenzione della scrittrice, ma la protagonista è soltanto il fulcro di una rete di personaggi sui quali si esercita una serrata – anche se non esplicitata – analisi psicologica.
è grazie a tale collegialità che la trama si sgomitola avvincente, rivelandosi frutto di una coralità di caratteri e di storie personali e, insieme, il disegno di una singolare geografia, basata su una frontiera. è questa che segna una separazione implicante un «di là», un territorio complesso, misterioso e lungamente tragico, separato da una linea artificiale a ridosso di quella che Alma chiama la «sua città a est», altro personaggio centrale della narrazione. «Che ci si interroghi su chi sia il personaggio principale è un buon segno, vuol dire che l’autrice ha voluto loro bene e ha dato a ciascuno il suo» afferma Adriano Sofri nella sua recensione su Review de Il Foglio, aggiungendo «ma è solo un gioco», conclusione, questa, che non sentiamo di condividere. Si tratta invece di una perizia narrativa grazie alla quale l’apporto di ogni singolo attore della vicenda concorre a completarla, nel porsi dialetticamente a confronto con gli altri e con il fondale geografico e storico, contribuendo a rendere alla fine esplicito e nitido il mosaico d’insieme: altro che solo un gioco!
La storia che ci viene proposta vede Alma, adulta, ritornata nella «sua città a est» che ha lasciato per trasferirsi nella capitale, una donna che «ovunque abbia vissuto l’hanno sempre scambiata per una che viene da un altrove». Scopo del viaggio è anche ricevere, racchiusa tutta in una scatola di legno di pino, un’eredità del padre ormai scomparso, fuggevole intermittente presenza nella sua vita di bambina e poi di ragazza. Mentre il recente lutto è ancora in via di elaborazione, il ritorno dalla capitale, dando la stura ai ricordi, induce il lettore a scivolare nella trama, che si manifesta vivacemente saltellando – “surfando” direbbe l’autrice – da un flashback all’altro. Il primo di essi vede Alma bambina che, come le accadeva due o tre volte all’anno, viene accompagnata dal padre sull’isola incantata dove si potevano incontrare elefanti, pavoni albini e zebre. Isola che sappiamo essere Brioni – ma Manzon, di norma assai reticente sulla toponomastica, non lo dice –, residenza estiva del Maresciallo Tito, «occhi di vipera», che avevano impaurito la bambina in un loro incontro ravvicinato.
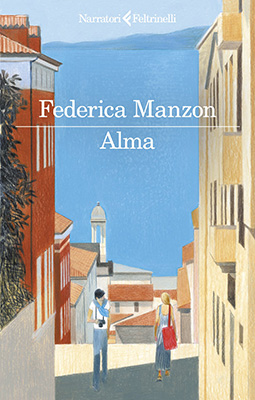
Alma
Feltrinelli, Milano 2024
pp. 270, euro 18,00
L’accesso ad ambienti così esclusivi comincia a gettare un minimo di luce sulla figura del papà di Alma, sulle misteriose ragioni delle sue prolungate assenze, quando «andava e veniva da casa senza che si potesse mai essere sicuri del suo ritorno. Era uno di cui non fidarsi. Fuggiva sempre verso est e a lei e a sua madre non restava che attenderlo, un’attesa eterna». L’uomo, come la ragazza scoprirà crescendo, lavorava in una posizione privilegiata nella cerchia dei collaboratori del presidente jugoslavo, col compito di scriverne ex post, raddrizzandoli, i discorsi, il più delle volte confusi, e vivendo quindi in una condizione di dubbio privilegio, munito di un passaporto rosso che gli consentiva di andare ovunque e ne agevolava gli spostamenti, almeno fino alla scomparsa, nel maggio 1980, dell’ingombrante datore di lavoro.
Sua madre condivide con Alma il tempo dilatato dell’attesa, nella casa sull’altopiano dove si sono trasferiti dopo la rottura con i genitori di lei, ostili al matrimonio della figlia con «lo slavo». A parte la coltivazione dei fiori, la donna «non sapeva fare niente di specifico, non cucinava, non aveva idea di come si infilassero le lenzuola sotto i materassi», il che non le impedì di collaborare con uno psichiatra di nome Franco, impegnato in una sua profonda riforma della «Città dei Matti», alla quale la donna apporterà le sue competenze botaniche. Con la madre, forse un po’anaffettiva, Alma avrà un rapporto poco intenso, scambiandosi a volte i ruoli nel rapporto madre/figlia.
Completa la famiglia di origine la coppia dei genitori della madre, che dispongono di una bella casa ordinata nel «viale dei platani», mentre loro due vivono in appartamenti diversi, due nonni che tutti avremmo voluto avere, due borghesi colti, affettuosi, legati a una cultura mitteleuropea in via di esaurimento nella «città a est». Quando può stare con loro, Alma si sente catapultata «in un’epoca distante anni luce dal disordine instabile di casa sua». Vanno insieme al Caffè San Marco, lei legge col nonno Die Zeit (lui ha voluto che Alma studiasse il tedesco), qualche volta, «di ritorno da un’uscita a vela o da una partita di bridge» arriva anche la nonna, una che le ha insegnato «a giocare a briscola e a barare a tresette», ma che le regala anche «le poesie di Marina Cvetaeva che in città non legge ancora nessuno».
In questo intersecarsi di problematiche triangolazioni di affetti fa inopinatamente irruzione, accompagnato dal padre di Alma, Vili, dieci anni come lei, «un bambino magro magro, gli occhi neri e una frangia scura di teppista», che indossa una maglia della Stella Rossa di Belgrado, figlio di due intellettuali della capitale jugoslava caduti in disgrazia nel regime autoritario «di là», come si scoprirà poco a poco. Il bambino entra così a far parte della scompaginata famiglia e sarà coprotagonista del romanzo, in un rapporto di intervallata vicinanza con Alma, destinato a sgretolarsi negli anni della giovinezza dei due ragazzini. Concausa della separazione quasi definitiva è anche la Storia, che si abbatterà sulle loro vite con la forza squassante che esercita sulle vite di tutti noi, accentuata per loro due dalla guerra sporca che disgregherà irreversibilmente la disgraziata Repubblica Federativa di Vili e del padre di Alma.

Lo schema narrativo del romanzo ripercorre, con accentuata sicurezza, quello di precedenti prove di Federica Manzon, segnatamente quella di un libro del 2020, Il bosco del confine (pubblicato da Aboca Edizioni). Il romanzo breve è un autentico antefatto di questo Alma, del quale anticipa alcuni contenuti. Anche lì abbiamo la figura di un padre internazionalista, le sue considerazioni sul confine, l’incontro a Sarajevo della protagonista – che conosciamo solo con l’affettuoso nomignolo di Schatzi – con un coetaneo, Luka, alla vigilia delle olimpiadi invernali del 1984, quindi la tragedia dell’assedio di Sarajevo, sotto il fuoco dei cecchini nel 1993, narrato da una lettera di Luka, e poi ancora il ritorno di Schatzi nella capitale bosniaca, dodici anni dopo, in una città alla fine precariamente pacificata, ormai meta di un allucinato turismo di guerra. Come si vede, il meccanismo narrativo è embrionalmente analogo a quello di Alma, prevedendo una prima parte che tratteggia gli anni dell’età evolutiva della protagonista segnati dalla presenza di un confine astratto e ondivago, che implica un «di là» misterioso, affascinante e drammatico, oltre al quale si sviluppa una seconda parte, segnata dalla tragedia del conflitto civile.
Manzon dispone di una mano particolarmente felice nel descrivere stati d’animo, emozioni, disorientamenti e solitudini dell’infanzia e dell’adolescenza, come già aveva dimostrato nel suo primo successo editoriale, il romanzo Di fama e di sventura (Mondadori 2011, premio Selezione Campiello). In Alma tale solo apparentemente facile predisposizione si fonde con il progetto di dare corpo alla descrizione di Trieste (non sveliamo proprio niente chiarendo che è questa la «sua città a est»), rivelata implicitamente per mezzo di una miriade di scorci, di dettagli, di ambientazioni, di sonorità che nel loro insieme restituiscono l’immagine complessa e luminosa della sua accogliente bellezza. Tutto ciò con lo strumento di una prosa che soltanto nel suo insieme si trasforma in poesia, con l’aggiuntivo merito di non ricorrere alla scorciatoia, divenuta popolare con le fortune di un turismo di massa in rapida espansione, della citazione di una sabiana “scontrosa grazia”, ampiamente abusata. E non è solo la Trieste materiale, quella delle torte Sacher, dei tuffi ai Topolini, del Porto vecchio col suo Magazzino 18 (dove anche i giovani corpi di Alma e Vili avevano preso a darsi del tu), degli gnocchi di susine e del tempio serbo ortodosso di San Spiridione quella che Manzon ci racconta: dietro ad essa, in un invisibile disegno sottotraccia, è anche la “Trieste di carta”, che fa capolino soltanto nel titolo del libro, citazione di Mattioni, ma che è inevitabilmente presente nelle assonanze di personaggi e situazioni presenti in testi di autori che qui hanno vissuto, di qua o subito di là della famosa linea di confine.
Trieste comunque non è la Fortezza Bastiani e il paese «di là» non è il deserto dei Tartari, ma un complicato intersecarsi di etnie, di alfabeti, di lingue, di campanili e minareti che i nazionalismi fanno impazzire come una maionese nel frullatore, ma con l’aggravante delle stragi, delle fosse comuni, degli stupri e delle torture che avrebbero fatto regredire un pezzo di Europa in un nuovo medioevo, alla fine del millennio. è lì che il romanzo si avvia a una sua plausibile conclusione, non prima di discostarsi in parte – come già era avvenuto nei capitoli finali del precedente Il bosco del confine – da un piano sostanzialmente privato ed intimistico ad uno intriso di problematiche di ordine sociale, civile, morale. Attratti come in un vortice nel centro del frullatore balcanico, a Belgrado, prima Villi e, sulle tracce di lui la stessa Alma consumano in un drammatico confronto tra il richiamo identitario che ha condotto lui a schierarsi dalla parte dei Mladić e di Arkan, lei a seguirlo nel vano tentativo, forse, di riportarlo indietro.
Ma non si conclude a Belgrado, la storia di Alma e di Villi che proseguirà ancora, ritornando nei luoghi dove era iniziata, dal momento che tra i non pochi personaggi del romanzo bisogna pur inserire anche il tempo, quello delle singole vite degli individui, quello che passa trasformandoli sui luoghi, quello collettivo che ci affanniamo a descrivere nei libri di storia, ma che invece si rivela in tutta la sua caleidoscopica trasfigurazione – ora impercettibile, ora tumultuosa e alluvionale – proprio nei racconti, nei romanzi, nei film e nella poesia, con la forza descrittiva e coinvolgente che nessuna esposizione “scientifica” riuscirà ad eguagliare.

Con Alma Federica Manzon ha prodotto il romanzo della sua piena maturità di scrittrice, preceduto da una lunga rincorsa che ad ogni falcata si faceva più sicura, avvicinandola alla meta, dagli esordi mondadoriani di Come si dice addio e quindi col suo Di fama e di sventura, con La nostalgia degli altri – altro romanzo di ragguardevole qualità narrativa – e poi col già citato Il bosco del confine. Sotto più di un profilo, la sua attività letteraria la inserisce stabilmente tra gli scrittori che, dall’inizio del secolo passato, hanno edificato realtà e mito di quella “identità di frontiera” che Ara e Magris hanno contribuito a illustrarci. Lo ha fatto scegliendo un percorso accidentato e difficile, dove ha proceduto con passo sicuro, con la perizia narrativa di cui parlavamo più sopra, ma soprattutto con una sapientia cordis della quale dovremmo esserle grati.
Soprattutto da queste parti.



