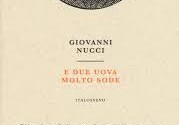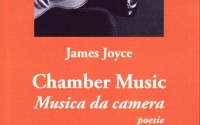Che farò senza Euridice?
Il Ponte rosso N° 28 | narrativa | ottobre 2017 | Walter Chiereghin
di Walter Chiereghin
Dopo una proficua attività saggistica quale storica e critica della letteratura slovena, affiancata all’attività di traduttrice nonché regista radiotelevisiva e operatrice culturale, Tatjana Rojc debutta alla grande come narratrice, firmando il romanzo La figlia che vorrei avere, libro che è stato scritto direttamente in italiano e pubblicato nel settembre scorso da un’importante Casa editrice di rilievo nazionale.
Scopertamente autobiografico, il libro narra con acuminata introspezione psicologica le vicende, ma soprattutto le risonanze interiori degli avvenimenti che si succedono nel percorso biografico, connotato fortemente dall’appartenenza della protagonista, Sanja, alla comunità slovena triestina. Tale appartenenza risulta problematica, ma viene vissuta con consapevole intensità e fierezza, tra l’altopiano carsico e la riviera di Barcola. È quella in gran parte l’ambientazione del romanzo, nella scoscesa dimensione da Contovello alla marina, nei terrazzamenti (pàstini, come usa dirsi a Trieste) che insistentemente riaffiorano nelle pagine di Boris Pahor, da quelli ridenti e costellati di agrumi lungo le rive del Garda, richiamati nel suo La villa sul lago, a quelli sinistri del lager di Natzweiler-Struthof, descritti nel capolovaro pahoriano Necropoli, in inquietante analogia con la topografia dell’Inferno dantesco. In una dimensione assai più pacificata e serena, su quelli stessi scoscendimenti del terreno vive anche oggi il grande scrittore sloveno, che è anch’egli personaggio, co-protagonista anzi, del romanzo del quale stiamo parlando, nel quale viene citato col solo nome di battesimo.
Mi corre l’obbligo, a questo punto, di dichiarare per inciso che chi scrive si considera amico della Rojc e, certo con la dovuta deferenza, anche di Boris Pahor, per cui può darsi che il giudizio critico sul libro e soprattutto sui protagonisti che lo animano sia almeno in parte influenzato da tali vicinanze, che ad ogni modo non possono offuscare la valutazione positiva di questa prima prova narrativa dell’autrice, cui va preliminarmente riconosciuto il merito di aver tratteggiato con sincerità ed acutezza tanto se stessa quanto gli altri personaggi che animano le sue pagine.
La prima figura presente fin dalle righe di apertura del libro accanto alla protagonistà è in realtà un’assenza, in quanto Nora, cugina della madre di Sanja, irrompe nella narrazione da morta (la prima di una non esigua schiera) evocata nell’angoscia della perdita e poi, ricorrentemente, riaffiorante nella memoria della protagonista, a segnare i più significativi passaggi della sua esperienza di donna. È lei che, prima di perdersi nel suo destino di depressione e di alcolismo, fornisce il titolo al romanzo quando, parlando della più giovane Sanja, affermò che avrebbe voluta avere come figlia. La figura materna e disperata di Nora riemerge come un fiume carsico nella memoria e nella riflessione introspettiva nei passaggi più ardui nella vita di Sanja, che d’altro lato trova in Boris, celebrato scrittore e intellettuale cardine della comunità slovena triestina, una singolare amicizia e un approdo di confidenza e di confronto che ha ragione dei diversi decenni di differenza d’età tra i due. «Boris era un bagaglio enorme che le aveva invaso l’anima, toccandola e plasmandola secondo alcuni principi che, ora doveva riconoscerlo, erano quelli di suo padre, più che di sa madre. Boris era un padre, dunque? O l’alter ego? Un amico? L’amore? […] Avevano vissuto insieme un’intimità che andava ben oltre quel forbito lei, del quale nessuno dei due sentiva il peso» (p. 111). Questo ed altri simili passi fanno del Boris del romanzo una figura centrale, il deuteragonista della narrazione con il suo intenso ed epico vissuto, con l’impegno politico di strenua opposizione ai totalitarismi del Novecento, con la sua consapevolezza identitaria faticosamente raggiunta in anni nei quali essa era ferocemente avversata, con l’esperienza annichilente del lager, con l’inesausto magistero della sua scrittura, con la riconosciuta importanza del suo rapportarsi all’universo femminile. Numerose altre sono le figure che compaiono nella storia narrata dalla Rojc, ma nessuna di esse appare così nitidamente delineata come quella dell’intellettuale sloveno, che oltre alla funzione di interlocutore della protagonista assume su di sé anche quella di rappresentare la stratificazione storica, di costituire con la sua esperienza di vita il presupposto degli altri personaggi, in massima parte appartenenti a una generazione successiva, che le drammatiche vicende di cui Boris è critico testimone le ha vissute soltanto dalla lettura dei libri di storia o dai racconti dei più anziani. «Era un uomo che aveva vissuto un secolo intero, cosciente e capace di valutare l’umanità attraverso la sua esperienza. E si adoperava per far comprendere agli altri la necessità di un umanesimo che mettesse l’esistenza nella centralità del pensiero» (p. 144 e seg.).
La figlia che vorrei avere è un romanzo che, sebbene fortemente incentrato sulle esperienze di vita della protagonista, propone la rappresentazione di una storia collettiva, per la pluralità delle figure che vi compaiono, dal primo marito, coetaneo di Sanja e presto eclissatosi, a Leone, che gli succcedette, italiano, di trent’anni più anziano di lei, col quale imbastì una storia matrimoniale che ci viene presentata come la storia di una lunga crisi marimoniale. E poi il padre, rimasto vedovo, il fratello Mitja, musicista, la nipotina, la piccola Varka, l’amica e confidente Alda: un microcosmo legato da fili emotivamente fortissimi alla protagonista, anche se spesso, ciascuno di tali fili a suo modo, problematici. E inoltre, ancora, le figure di quelli che non ci sono più – quali la madre, un giovane maestro di canto, e, soprattutto, Nora – oppure che, come un figlio che non si è voluto venisse al mondo, non sono mai stati, e tuttavia continuano incessantemente a interrogarla e a giudicarne l’operato ad ogni singolo passo del suo cammino nella vita, proiettando la loro ombra sui giorni del presente di Sanja.
Un presente del quale la donna è profondamente partecipe, quando vuole recarsi con un’amica alla festa notturna per la caduta del confine che tanto ha influito nel recente passato della sua città, o quando considera con sbigottita angoscia la disumana quotidiana ecatombe dei migranti inghiottiti dal mare o respinti da nuove barriere di filo spinato.
È ancora da aggiungere che con questo romanzo la Rojc si rivela una provetta paesaggista, capace di individuare in ogni singolo dettaglio di quanto fisicamente le sta attorno un elemento funzionale a comporre l’accattivante immagine della città nel golfo, nella sua cheta bellezza che ha ragione delle sue contraddizioni, dei conflitti che oggi paiono appianati, ma che sono stati in un recente passato il doloroso portato di un territorio di frontiera, dove si sono anche duramente confrontate l’anima latina e quella slava di un territorio per molti aspetti unico nella sua varietà, ma anche nelle sue passioni e nelle sue fragilità. Per Sanja, per Tatjana Rojc, una Trieste intensamente vissuta dall’altopiano al mare, soprattutto il mare, spontanea metafora della libertà, ma anche dell’insondabilità dei suoi abissi, specchio e al contempo nemico implacabile, come già aveva messo in luce Baudelaire nelle sue Fleur du mal.
Copertina:
Tatjana Rojc
La figlia che vorrei avere
La Nave di Teseo, Milano 2017
- 195, euro 14,00