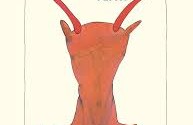Da Trieste al fumo di Londra
Gabriella Ziani | Il Ponte rosso N° 62 | novembre 20 | profili
Vita, scrittura e bottiglie di latte di Silvia Risolo
di Gabriella Ziani
La bottiglia del latte fresco depositata quotidianamente sulla soglia degli appartamenti era a Londra, quanto meno nei sobborghi fatti di infinite villette accostate, un segnale di presenza, assenza, salute o malattia di chi li abitava, specie se non veniva puntualmente ritirata. Fu così, di fronte a molte bottiglie di latte lasciate a inacidire davanti alla porta, che in un gelido gennaio del 2004 i vicini si preoccuparono della sorte dell’inquilina di 2 Davmor Court, in Manor Vale, a Brentford, un distretto del borgo di Hounslow che si trova nella cintura Ovest della “Great London”, non distante dai famosi Kew Gardens, là dove il fiume Brent si butta nel Tamigi.
In quell’abitazione di mattoni bianchi e rossi fu trovato il corpo senza vita di una donna che si era spenta in totale solitudine, pochi mesi prima di compiere 84 anni: era Silvia Risolo, nata a Trieste il 7 agosto 1920, trasferitasi in Inghilterra nel 1949 come insegnante di greco e latino in collegi femminili, e raffinatissima (e sfortunata) scrittrice, figlia di quella Amalia Popper il cui nome era diventato celebre nel mondo per essere stata non solo allieva, ma anche musa di James Joyce e modello per la Molly Bloom dell’Ulisse, nonché nel 1935 traduttrice col titolo di Araby di cinque racconti del geniale irlandese tratti dalla raccolta Dubliners (Gente di Dublino).
Negli anni Novanta, in una corrispondenza privata, aveva raccontato di certi eventi sgradevoli che avevano reso la sua vita d’immigrata londinese un incubo di dispiaceri, costringendola nel 1977 a lasciare il bel quartiere upper class di Kensington per rifugiarsi nei sobborghi in cerca di pace, ma senza trovarla: «Io sprofondai in un terribile abisso d’egocentrismo e inferiority complex – scriveva – e non mi riusciva più di scrivere in modo obiettivo e da artista, e mi rinchiusi in casa, in solitudine e isolamento completi, odiando il passato, anche i miei libri, anche Trieste, intenta a dimenticare tutto e tutti».
Eppure proprio in quegli anni, sollecitata dal Piccolo che l’aveva rintracciata e invitata a riprendere la penna, scrisse ed ebbe pubblicata sul quotidiano una dozzina di racconti in cui tornava vivida, amara ma divertente, la cifra tematica e stilistica di tutta la sua piccola e preziosa produzione, dalla prima raccolta Il bigliettaio di Leicester Square, pubblicato nel 1953 dalla Libreria editrice fiorentina, a è tardi ormai, Madeleine, edito da Vallecchi nel 1957, ai romanzi Cargo a Sud
(Cappelli, 1959) e L’ammirevole e fortunatissima Letizia Lloyd (Rebellato, 1965). Un sorprendente quadro di società inglese, quest’ultimo, in cui attorno alla protagonista che gira in un carosello d’amicizie s’intrecciano oscure perfidie in guanto di velluto, drammatiche vicende di omosessuali, istigazioni al suicidio, derive annebbiate dalla droga, il tutto maneggiato dalla “ammirevole e fortunatissima” che difende con le unghie la propria condizione di “single”, appagata da una casa linda e arredata con gusto, dove una tazza di tè non manca di corroborare lo spirito.
è proprio l’estrema solitudine, e specialmente quella delle donne (subìta oppure scelta) il primo dei temi di fondo di queste opere squisitamente british per stile, ironia e ambientazione. Il secondo è Londra, la metropoli rumorosa, nera di smog e fuliggine, ostile per il clima sempre gelido in cui la proverbiale nebbia si alterna a vento e neve, brulicante di gente frettolosa, spesse volte indifferente, ostile o anche cattiva, dove il singolo si perde e sperde, assordato dal traffico dell’ora di punta e dal rombo della subway.
Ma un ritratto ancora più ampio di quella Londra Silvia Risolo mirabilmente fece nei suoi reportage per una delle riviste ancora oggi considerate tra le più importanti nella storia del giornalismo novecentesco italiano, Il Mondo diretto da Mario Pannunzio, al quale spedì, fra il 1959 e il 1966 (quando la rivista momentaneamente sospese le pubblicazioni) cinquanta ampi articoli che uscivano sotto le testatine “Aria di Londra” e “Posta da Londra”. Qualche articolo di colore pubblicò anche sul Corriere della sera in una pagina dedicata a “La donna e il mondo”: Rubavo soltanto quando avevo soldi (febbraio 1964), Il vademecum per comprare un uovo (12 giugno 1965), Con tromba e tamburo, sui passatempi inglesi (4 settembre 1965), Due ore al giorno dedicate all’erba e ai fiori (25 settembre 1965).
Negli anni Quaranta aveva esordito sul Piccolo, scrivendo un articolo sui libri gialli e un altro su Tucidide 24 secoli dopo (pubblicato il 21 novembre 1942, a 22 anni). Due romanzi, Il canadese bianco (1960) e La casa di Via dei Poveri (1973), erano rimasti – lo rivelò lei stessa nel periodo in cui spediva a Trieste i suoi ultimi racconti – incompiuti e inediti, per ragioni sia editoriali che familiari. Un filo di fortuna la sfiorò come scrittrice per due volte, senza raggiungerla. Nel 1952 in una lettera spedita da Venezia il poeta Diego Valeri segnalò ad Aldo Palazzeschi, pare in accordo con Giani Stuparich, Il bigliettaio di Leicester Square fra i libri da presentare al Premio Venezia di quell’anno (come risulta dalle ricerche di Gloria Meneghetti, che ha curato nel 2004 per le romane Edizioni di storia e letteratura e con l’Università di Firenze il carteggio Palazzeschi-Valeri 1934-1972). Nel 1957 è tardi ormai, Madeleine entrò in lizza per il Premio Strega. Vincitrice fu Elsa Morante con L’isola di Arturo.
C’era un’amarezza fatta di tante cose, in Silvia Risolo, e se noi oggi siamo pronti a suggerire con calore che questi libri e reportage vengano a pieno merito ripubblicati, non possiamo ignorare il fatto che l’autrice ci insegue con quel suo viso ovale, così somigliante a quello della madre, raggrinzito di premonitrici severità e contrizione. Scrisse in una lettera accompagnatoria dei racconti “triestini”: «A mia madre, poveretta, finché era viva, nessuno è venuto a dirle ‘sei scrittrice’ e a farle onore, e ai suoi occhi l’aver tradotto nella sua lontana gioventù alcuni racconti di Joyce non la rendeva scrittrice; ma, dopo morta, quando non le serve, tutto questo fracasso. – Accadrà anche a me? Finché vivo e potrei, nella mia vecchiaia, resuscitare il mio nome e chiarire il mistero della mia scomparsa, e insomma mettere le cose a posto, nessuno aiuta; poi, forse, dopo morta, Silvia Risolo di qua, Silvia Risolo di là…».
Detto che quanto meno “il giusto” le spetterebbe di diritto, è ora però di mettere in ordine le tessere, perché se il mondo romanzesco della Risolo è sorprendentemente accattivante, anche la sua stessa vita – e le radici di quella – sono un robusto romanzo, che deve cominciare dai genitori. Anche perché proprio da quel milieu («i miei genitori erano persone tremende») Silvia decise di scappare nel 1949, turbata dagli anni di guerra, con una gioventù minata dalle leggi razziali, e il lutto bruciante di una zia, Lisetta, morta assieme al marito, il generale Cesare Luzzatto, nelle camere a gas di Auschwitz, notizia che la raggiunse quando era già oltremanica.
La storia inizia dunque a Trieste. Amalia Popper (1891-1966), figlia del grande imprenditore delle spedizioni Leopoldo Popper, arrivato a Trieste dalla Boemia per farvi affari, come tanti altri altoborghesi del tempo prende lezioni d’inglese da Joyce, tra il 1908 e il 1909, nella casa di via Alice 16 sul colle di San Vito, episodi che lo scrittore trasfigurerà nel libretto Giacomo Joyce dando adito a molte illazioni su chi fosse la pupilla amata di cui si parla, finché il primo grande biografo dello scrittore, Richard Ellmann, accreditò con eco mondiale che la fanciulla prediletta fosse proprio Amalia.
La quale studia poi all’Università di Firenze, dove conosce – e sposa nel 1914 – il pugliese Michele Risolo, che dapprima sarà collega di Stanislaus Joyce, il fratello di James, alla Scuola superiore di commercio Revoltella, e quindi inizierà una carriera giornalistica al Popolo di Trieste, diventandone fin direttore, nel 1933, quando il foglio era già l’organo ufficiale del partito fascista. Lascerà la carica nel 1938, alla promulgazione delle leggi razziali: la moglie Popper è ebrea. La coppia ha tre figli: Angiolo Leopoldo (1915), Silvia (1920), Fausto (1924).
Per sfuggire alla persecuzioni antiebraiche Amalia e i figli saranno fatti partire per Firenze, dove il padre li raggiungerà a guerra finita. Silvia s’iscrive a Lettere, ma – così raccontò lei stessa – quando la cattedra di Letteratura italiana passa da Arnaldo Momigliano (cacciato perché ebreo) a Giuseppe De Robertis (meno accattivante come docente) si trasferisce a Lettere antiche, e sarà proprio la conoscenza del greco – cosa rara in Inghilterra – ad aprirle le porte dell’insegnamento, forse più che la lettera di presentazione firmata da Stannie Joyce.
è dunque nel 1949 che Silvia sceglie l’Inghilterra. Non sopporta le terribili liti che amareggiano la vita familiare (mai per problemi politici o religiosi, proprio per pessimi caratteri), e vuole conoscere il paese che ha vinto la guerra, lasciarsi alle spalle le ombre scure della persecuzione. Nel settembre di quello stesso anno trova subito lavoro d’insegnante in un collegio femminile nell’Ovest dell’Inghilterra, vi si ferma un anno e mezzo, poi si sposta in un’altra scuola per giovinette di buona famiglia, a Burgess Hill, nel Sussex. Ci sta, e bene, per cinque anni, ma è come vivere in un romitorio per quanto di lusso (sul Mondo rivelerà tanti dettagli relativi alla splendida location, con parco e ippodromo, ma anche torbide onde saffiche celate da quelle mura, vedi Il bacio di Lesbia, 27 agosto 1963).
Si sposta dunque nella metropoli, in zona Kensington, ma come si evince benissimo dalle sue corrispondenze per la rivista di Pannunzio c’è lei stessa dietro la folla di donne sole con pochi soldi (meno nutrito ma non inesistente l’elemento maschile nelle medesime condizioni) che affittano una sola stanza, con il bagno in comune, talché vi sono condomini interi abitati da single impegnati ad arredare pezzo a pezzo il minuscolo nido, e a camuffare con fantasia l’angoletto della cucina (vedi I cuori solitari, Il Mondo, 12 dicembre 1961, e soprattutto Buon vicinato, 25 gennaio 1966, dove si parla di «gente che ama viver sola come me… Dove vivo io vivono in questo brutto modo altre sei donne…»). è anche l’effetto del poderoso inurbamento che Londra conosce in quegli anni, con le ovvie conseguenze della scarsità di alloggi, dell’aumento degli affitti, dello sviluppo dei quartieri in periferia.
è qui però che la Risolo riprende a scrivere, trovando nel padre Michele il primo e prediletto lettore di racconti e romanzi, e sarà lo stesso padre a occuparsi della pubblicazione dei libri, che tuttavia non avranno mai grande diffusione. Per stessa ammissione della scrittrice, quando il genitore morì, nel 1975, Silvia sentì di aver perso il proprio interlocutore privilegiato e agente letterario (nonostante i rapporti personali fossero molto critici), e la penna si fermò: «Non c’era chi mi leggesse» (da una lettera).
Un altro fatto era venuto a sconvolgere l’esistenza della triestina. Nella corrispondenza allegata ai racconti per Il Piccolo raccontò che nel 1967 – un anno prima di ottenere la cittadinanza inglese –, la sua persona pare fosse stata associata a gruppi “eversivi” di estrema sinistra, per cui ebbe noie con la polizia, e da allora si sentì minacciata, spiata, malvista, insicura, ingiustamente calunniata e guardata di storto oltre che presa in giro. Decise di lasciare Londra, e approdò appunto al borgo di Hounslow, affermando che tuttavia anche in quell’angolo defilato la gente continuava a volerle male, a sbirciarla perfino in casa, addirittura leggendo a distanza ciò che andava scrivendo (vedi il racconto Finestre cieche, Il Piccolo, 18 dicembre 1995). Fatto o suggestione? Da qui comunque l’autocostrizione alla clausura, la difficoltà di rispondere perfino al telefono, la paura delle telefonate mute o minacciose di giorno e di notte, che appare peraltro descritta già nei testi per Il Mondo (vedi Macbeth al telefono, 24 settembre 1963).
In questa nutrita serie di corrispondenze col prestigioso giornale di Pannunzio, costanti per scrittura nitida e fresca, esempio di giornalismo letterario sapientemente governato, la Risolo s’incaricò di spiegare ai lettori italiani com’era Londra dal punto di vista sociale e umano. E la Londra degli anni Sessanta, vista con i suoi occhi e la sua esperienza, è certamente un mondo difficile e ostico, dove gli intellettuali “posano” e frange di ragazzi animano bande pericolose di teddy boys, dove nei negozi si è trattati con sussiego se non ignorati, e il proverbiale understatement britannico si traduce in fredda indifferenza anche di fronte a furti in casa o tentativi di suicidio (vedi I Britanni indifferenti, 24 ottobre 1961, Un ladro in casa, 20 novembre 1962, Il club dell’alcool, 7 maggio 1963, I poveri di Natale, 14 gennaio 1964 o appunto L’indifferenza, 16 novembre 1965), e dove comunque bisogna imparare nuovamente a stare al mondo (Il piccolo codice, 11 giugno 1963).
Mai sposata, niente figli, la Risolo si trasfigurò in questa umanità minore, che poco condivideva i trionfi e i lussi della Londra ricca e glamour, sperimentando piuttosto grigie e desolate periferie con negozietti gestiti da asiatici che fan paura alle vecchiette, sempre sole o di nuovo sole (vedi Non sono cattivi, Il Piccolo, 22 maggio 1993), e dove anche gli uomini sono strumenti a volte derelitti di una macchina complessa, la metropoli, che impone ritmi disumanizzanti e solitudini irrimediabili – tutto ciò già nei racconti de Il bigliettaio di Leicester Square e segnatamente nel racconto omonimo che apre la raccolta, col disperato e devastato bigliettaio della metropolitana. Quanto alle coppie, franano in rivoli di non innocente ambiguità, oppure si ritrovano ancora in due ma anziani e fragili emotivamente, con le gambe stanche e incapaci di reagire alle angherie dei giovani.
Fedele a un frasario volutamente “basso”, ma dotato di forte potere evocativo nella sua adamantina precisione, in cui a volte si percepisce il profumo del ron ron che Cesare Garboli coniò per la ritmica prosa di Natalia Ginzburg, Silvia Risolo infine non ha mai cambiato idea e l’ha scritto a chiare lettere nei decenni: l’umanità è cattiva. Questo è quanto aveva capito e sperimentato. La parola quasi infantile nella sua semplice nudità, “cattivo”, ricorre costantemente anche nei reportage, ma forse nulla lo sintetizza meglio di una frase messa in bocca a uno dei personaggi femminili de L’ammirevole e fortunatissima Letizia Lloyd: «La gente è cattiva, Letizia. Una volta non lo sapevo. Oscar mi faceva vivere con gli occhi bendati. Oscar era gentile, si sforzava di far del bene; ma sapeva che la gente è cattiva. Appunto perché lo sapeva e perché aveva sofferto, cercava di non esser cattivo anche lui come tanti, di non far soffrire nessuno, d’aiutare. Io, tutto questo, lo capivo in modo solo vago. Ma ora so. Ora vedo chiaro. Gli uomini son cattivi!». E la Risolo si chiuse per sempre in casa, fino a morire nel suo guscio di protezione, senza anima viva intorno, senza che il telefono squillasse, e senza ritirare la bottiglia del latte quotidiano.