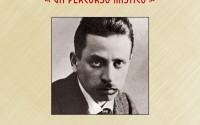CINEMA – La ruota delle meraviglie
cinema | Pierpaolo De Pazzi
 La ruota delle meraviglie (Woody Allen, USA 2017)
La ruota delle meraviglie (Woody Allen, USA 2017)
di Pierpaolo De Pazzi
Valutazione 2/5
Primi anni ’50, parco di Coney Island: Ginny, attrice fallita e cameriera insoddisfatta in un diner, s’innamora di Mickey, bagnino e aspirante commediografo. Ma è sposata con il giostraio alcolizzato e violento Humpty, la cui figlia Carolina è ora in fuga dal mafioso italiano che fu causa del suo allontanamento dalla famiglia, proprio quando sua madre giaceva sul letto di morte. Inseguita da un paio di good fellas, si rifugia proprio lì, facendo innamorare di sé il superficiale bagnino Mickey e chiudendo così il giro di questa (mal oliata) ruota delle meraviglie. L’unico elemento che sfugge a questo giro vizioso è Richie, figlio piromane di Ginny e forse la figura più interessante di questo carillon delle disgrazie, su cui torneremo in conclusione.
Quello di Coney Island fu uno dei primi parchi divertimento del mondo, il primo a chiamarsi Luna Park: Luna era infatti il nome di una delle prime attrazioni, e anche della figlia del fondatore. Funestato da una serie di incendi dolosi, di cui fu sospettata la mafia, nel 1946 era già chiuso. Il film di Allen, quindi, si ambienta in quello che è un non luogo per eccellenza, commettendo in più volutamente un anacronismo, mettendo in scena un passato immaginario, ingannevole e sfuggente e aggiungendo straniamento con le luci nostalgiche di Vittorio Storaro, che si ispira all’iconografia rutilante e fasulla delle pubblicità anni ‘50.
Ecco, l’illuminazione e la fotografia sono proprio gli aspetti migliori del film, mentre la storia, infarcita di riferimenti al teatro, dalla tragedia greca a Eugene O’Neill, proprio non convince. La sceneggiatura gronda del cupo pessimismo alla maniera dell’ultimo Woody e non aiuta gli attori, tutti abbastanza deludenti, impediti a relazionarsi tra loro da battute monologanti, in cui ciascuno racconta la propria vicenda. Se questo è funzionale a sottolineare la loro solitudine,non crea amalgama e li riduce un po’ a marionette. In particolare Jim Belushi riesce a battere tutti i record di frequenza dell’interiezione «cazzo», senza dare credibilità al personaggio. Juno Temple è una ninfetta meno sexi del solito, mentre Kate Winslet è piuttosto manierista, facendo rimpiangere la sua interpretazione, per altro molto simile, in Revolutionary Road. Il bagnino Justin Timberlake, presente nel cast per attirare al botteghino i propri fan, che altrimenti mai andrebbero a vedere un film di Allen, guarda fastidiosamente in camera con un espediente da teatro greco, ma non è assolutamente all’altezza delle tragedie che scatena.
Non resterebbe che invocare, prendendo una battuta del film, «Oh Dio, risparmiami questo brutto dramma», se non avessimo promesso di tornare al piccolo Richie, il figlio incendiario di Ginny. Non possiamo non simpatizzare per lui, perché anche noi vorremmo eliminare col fuoco le menzogne e le bassezze morali in cui va affogando.
Richie, che non va a scuola per andare al cinema, come faceva Antoine Doinel in I 400 colpi, è in qualche modo l’alter-ego del regista. Se lo è, il breve episodio in cui appicca un rogo, proprio nello studio della psicanalista che lo dovrebbe curare, ci mostra dilagare il pessimismo assoluto di Allen, che intacca ormai anche la sua fiducia nella psicanalisi e, in ultima istanza, nella stessa possibilità dell’arte di essere terapeutica e di offrire al pubblico un’occasione di liberazione catartica.