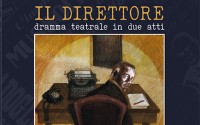IL “DRAMMA” DELLA RICOMPOSIZIONE Il lascito intellettuale di Slataper in Biagio Marin
Speciale Scipio Slataper
 “Festa di luce”, “volo d’ala”, “ragione d’incanto”, “cielo profondo della primavera”, “occhi chiari di ragazzo puro”: sono alcune delle suggestive immagini con le quali Biagio Marin, nei vari saggi dei Delfini di Scipio Slataper, stigmatizza, e in qualche modo rende canonico, il ritratto fisico e morale di Scipio Slataper, il “primo poeta di Trieste”, che sarà lungo tutta la sua vita un punto di riferimento imprescindibile, una sorta di cartina al tornasole per misurarsi con il presente e valutare quanto è rimasto di una straordinaria stagione culturale, quella della sua formazione, negli anni Dieci, nell’ambito della Voce.
“Festa di luce”, “volo d’ala”, “ragione d’incanto”, “cielo profondo della primavera”, “occhi chiari di ragazzo puro”: sono alcune delle suggestive immagini con le quali Biagio Marin, nei vari saggi dei Delfini di Scipio Slataper, stigmatizza, e in qualche modo rende canonico, il ritratto fisico e morale di Scipio Slataper, il “primo poeta di Trieste”, che sarà lungo tutta la sua vita un punto di riferimento imprescindibile, una sorta di cartina al tornasole per misurarsi con il presente e valutare quanto è rimasto di una straordinaria stagione culturale, quella della sua formazione, negli anni Dieci, nell’ambito della Voce.
Attraverso Marin possiamo tracciare, più in generale, un profilo di come è stata recepita ed elaborata l’eredità slataperiana: si tratta di un confronto che inizia sulle pagine dell’ Azione nel 1922 (lo stesso anno del saggio su Slataper di Giani Stuparich) e si inoltra fino agli anni Settanta nei diari.
Rispetto a Slataper e alla sua statura culturale, Marin segnala spesso uno “stordimento” da provinciale, la sensazione di essere un “pigmeo”. La condivisione è invece totale sul piano umano, nel caos e nella passione presenti in entrambi gli scrittori che trovano un punto d’incontro “nella gioia della viva creativa espressione, nella gioia divina della poesia”, nell’idea di una “poesia ‘umana’, espressione di una forza unificatrice vittoriosa per merito d’un atto supremo, non solo di coscienza, ma di volontà”. In entrambi è perentorio il “bisogno che tutto me sia esplicato, tutta la mia umanità”, nella prospettiva di una spiritualità creativa, di una personalità che “non è verità se non in quanto cerca di educare altre personalità, in quanto cerca di continuarsi a migliorare negli altri”.
Lo slancio volontaristico, che vuole suscitare una sempre più larga condivisione e cooperazione ideale incentrata su verità collettive e che si traduce anche nella tensione a “scrivere un libro dove ci sia tutta l’umanità” e a liberare la voce delle cose, è la cifra spirituale che contraddistingue un’intera generazione di ‘scrittori di frontiera’, che guarda all’Italia con l’ «ingenuità centroeuropea» di cui parla Pasolini e appare perennemente in ritardo e inadeguata rispetto all’oggetto del proprio amore smisurato, ma che tenta di trasformare questa difficoltà e la sofferenza per l’incomprensione degli italiani nei confronti dei giuliani in una risorsa positiva. In Marin, come in Slataper, la “propensione giuliana all’autobiografismo” (come la definisce Renate Lunzer) si acuisce passando attraverso l’esperienza vociana, e si pone come strumento privilegiato di conoscenza di una realtà dicotomica e conflittuale, di superamento, sempre irrisolto, del senso di marginalità e della propria infelicità personale in una prospettiva universale: l’ossessione vociana della verità e la convinzione nella necessità di una “formazione di tutto l’uomo e al di sopra delle preoccupazioni individuali utilitarie”, oltre al radicamento in strutture di pensiero ambivalenti che richiedono continui processi di mediazione e configurano una identità dinamica, una idea di cultura come “traduzione”, determinano un atteggiamento antiretorico e antiletterario che vuole esprimere una “sintesi di cultura e di vita” e si traduce spesso in posizioni antidogmatiche.
Accanto al bisogno di verità c’è quindi sempre l’esigenza della confessione, del giudizio portato fino in fondo, fino all’autocritica: Marin e Slataper riassumono tutta la complessità della Venezia Giulia, che è la complessità dei marginali, degli uomini di frontiera che cercano una salvezza nell’espressione del loro dramma, in una pratica ipertrofica delle passioni nazionali che, oltre a evidenziare la debolezza dell’intellettualità triestina e la sua separatezza, rischia di risolversi in una dimensione astratta ed eccessiva, come dimostra lo stesso Marin nel saggio Coscienza nazionale. Entrambi gli scrittori hanno tuttavia la consapevolezza di questo rischio che produce un sentimento esasperato della storia e della politica, e perciò, anche se in modo contraddittorio, affermano l’idea dell’irredentismo culturale, contrapposto da Slataper all’intransigente irredentismo politico che per Trieste risulta pericoloso come “la scure sulle radici”.
Anche l’adesione ai valori del mazzinianesimo passa attraverso l’identificazione nella figura di Scipio Slataper, critico nei confronti della falsa italianità dei nazional–liberali e del loro irredentismo “fighi e zibibe” ed emblema di una ulteriore, drammatica, nevrosi, dal momento che, per Marin, il “dissidio e la lotta per l’indipendenza nazionale assorbivano tutta la possibilità politica della nostra generazione”.
Le contraddizioni dell’eredità slataperiana emergono in Marin soprattutto dopo la perdita sul fronte sloveno del figlio Falco, emblema di una nuova generazione di intellettuali giuliani che, oltre alla possibilità di una rigenerazione, ha rappresentato con estrema coerenza la “continuità del sacrificio” ed è stata tradita dagli ideali dei padri, che si sono rivelati vere e proprie colpe tragiche di un destino immodificabile. Si inasprisce la consapevolezza della zona grigia che si frappone tra la realtà e l’Ideale, già presente anche nel figlio, nella sua tensione spirituale destinata inevitabilmente allo scacco, che ripresenta lo “iato irreparabile tra la vita e il valore”, l’inconsistenza di una proiezione puramente immaginaria e mitopoietica. Si sviluppa un processo di spietato revisionismo interiore che riconosce la “tragica illusione” della volontà di “costruire nel sangue l’unità degli italiani”, superando così l’isolamento dell’intellettuale con l’attivismo e l’interventismo.
In Marin si ripresentano il sofferto confronto slataperiano con l’«anima in tormento» di Trieste e il tentativo di fondare su essa e sulla sua “originalità d’affanno” una cultura, una fondazione che, come sottolinea Magris, “reca in sé una contraddizione profonda, lo slancio vitale proteso all’edificazione e la dura repressione che esso impone in nome di quella meta, finendo per negare se stesso e per convertire la propria energia in pulsione di morte la quale intorbida la strenua passione di costituire una Kultur, perché oscuramente fa sentire che non è possibile fondarla in modo duraturo”.
La tensione a comporre l’individualità e l’esperienza nell’unità solida della dimensione dello spirito, in un “blocco formidabile, uno, compiuto in sé” che non può essere “sminuzzato” sostituisce tuttavia alla vita una immagine di essa ed è una forma di autoinganno: Negrelli al riguardo parla di “cancellazione del diverso nella paranoica estensione dell’io, che cerca così di nascondere la propria intima debolezza: ma inutilmente, perché quell’immagine è solo negazione di ciò che non si sa più ricomprendere; riconoscimento dell’impotenza a creare, tautologica affermazione di sé”.
L’ostentazione di una volontà illimitata e di una immagine che non corrisponde alla realtà ma della cui verità ci si vuole persuadere, rivela il dramma di una città e di una borghesia che vogliono presentarsi all’esterno come compatte e capaci di rappresentare l’intera realtà, politica, sociale e umana, ma che in realtà non hanno storia e occultano la loro debolezza costitutiva attraverso l’uso politico del mito astratto della nazionalità.
Nella corrispondenza con Marin, anche Gino Brazzoduro mette in rilievo i risvolti oppressivi dell’individualismo del poeta gradese e, con essi, gli aspetti contraddittori di tutta la generazione intellettuale che aveva come suo nume tutelare Scipio Slataper, perennemente divisa fra etica e vitalismo, totalmente avulsa dai processi reali della storia e ripiegata, come la città di cui è espressione, in una ossessiva sublimazione ideologica.
Brazzoduro, al quale si può rimproverare di non tenere conto a sufficienza del contesto di esasperazione nazionalistica in cui si forma la generazione di Slataper e quindi della ingenuità ideologica che la caratterizza, prende una posizione certo insolita che si risolve in una concezione diversa dell’identità, nel senso di un dialogo costruttivo contro ogni fissazione dogmatica ed etnocentrica, del rifiuto netto di ogni gerarchia dominante e di ogni appartenenza esclusiva.
Marin, che cerca comunque il dialogo per capire meglio le ragioni altrui e sé stesso, non riesce a comprendere il punto di vista di Brazzoduro e l’eliminazione del concetto di patria, che resta per lui quello mazziniano, fondato sulla lingua e sulla superiorità culturale e quindi su una idea di confine come qualcosa che divide, separa, rispetto a popoli più ‘barbari’ e inferiori, diversamente da Brazzoduro che invece dichiara che «ogni confine passa in me, mi attraversa, mi divide, ma non mi spacca drammaticamente, ma mi rende partecipe dei territori limitrofi: linea che congiunge”.
Rispetto al mito astratto e sovrastorico della patria ribadito da Marin, Brazzoduro rileva i rischi che un tale eccesso teorico e ideale può comportare e sostiene la necessità di calare questo mito nella vita quotidiana, ovvero il valore imprescindibile dell’esperienza e dei vissuti dei singoli individui, che prescindono da rigide definizioni o da quella mistificazione della realtà, che Vivante definiva «imperialismo utopico», pagata poi a caro prezzo.
di Gianni Cimador