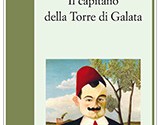La storia che leggiamo sarà forse sbagliata?
Francesco Carbone | Il Ponte rosso N° 74 | novembre 2021 | scienza
Il racconto storico è il racconto della forza, e la forza è ciò che più di tutto gli uomini idolatrano
di Francesco Carbone
«…ma l’ultimo giorno Einstein capitolò.»
(Benjamín Labatut, Quando abbiamo smesso
di capire il mondo, Adelphi 2021)
Sarebbe da chiedersi perché i libri di storia siano tutti sbagliati. Prendiamo il Novecento: non vi è saggio che provi a darcene un quadro in cui i capisaldi non siano le due guerre mondiali, i cosiddetti totalitarismi e la lunga guerra fredda. Dominano le ricostruzioni delle origini e delle conseguenze dei conflitti coi relativi massacri, torreggiano dittatori torvi e psicotici, alla lunga magari sconfitti ma ben più memorabili di leader democratici che appaiono, molto semplificando, per noi “buoni” ma impiegatizi. Quante cose ricordiamo di De Gaulle? E quante di Hitler?
Malgrado quasi un secolo della storiografia delle Annales, di microstoria, di sociologia e antropologia, soprattutto nelle scuole tiene il campo la storia politica: una sequela di metamorfosi del potere dai Cesari a Stalin e oltre. Simone Weil aveva scritto che Adolf Hitler, dal suo allucinato punto di vista, aveva vinto, avendo ottenuto quanto desiderava: la memoria, fosse anche dannata, il suo segno perenne attraverso il tempo: decine di pagine in tutti i libri di storia del mondo, una bibliografia sterminata in tutte le lingue, e film, documentari, anniversari. – E mentre i simbolici responsabili di sterminati cimiteri fanno i capisaldi del racconto, di chi ha sconfitto la poliomielite, debellato la tubercolosi, di chi ha salvato centinaia di milioni di vite non sappiamo niente. Ha scritto sempre Simone Weil: perché il racconto storico è il racconto della forza, e la forza è ciò che più di tutto gli uomini idolatrano.
Siamo costretti così ad ammettere che, in ogni caso, il quadro cha ci facciamo dello stesso tempo che abitiamo è drasticamente falsato; perché la storia sarebbe stata ben diversa, più che senza la politica, senza gli antibiotici, i vaccini, la scoperta del DNA, la chemioterapia, la chirurgia moderna e l’anestesia: tutte cose che non hanno una riga nei libri di storia e nel nostro paesaggio mentale.
Tutta questa premessa per provare a dire qualcosa di un libro bellissimo, tra saggio e romanzo, che sarebbe piaciuto a Manzoni: Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamín Labatut (Adelphi 2021). La figura fondamentale del primo racconto è Fritz Haber, che ovviamente quasi nessuno conosce. Eppure la nostra fugace vita, posto che fossimo comunque nati senza la sua invenzione, sarebbe incomparabilmente diversa se Haber (Nobel nel 1918) non fosse vissuto. Fritz Haber, controverso e tragico, e forse tanto geniale quanto stupido, inventò il modo di ricavare il preziosissimo azoto dall’atmosfera – che ne è piena – creando in laboratorio l’ammoniaca, che la natura produce soprattutto dalla putrefazione dei cadaveri. L’ammoniaca è la base dei concimi chimici. Haber la scoprì quando ormai scarseggiava sulla terra: se ne ricavarono fertilizzanti che salvarono «centinaia di milioni di persone dalla carestia», rendendo «possibile l’esplosione demografica attuale»: metà dell’azoto che sta nel nostro corpo lo dobbiamo a lui. Dalla scoperta di Haber viene il processo di produzione Haber-Bosch: «la scoperta chimica più importante del secolo». Oggi produciamo 150 milioni di tonnellata di ammoniaca all’anno (più del 28% la Cina). Prima dell’ammoniaca, l’azoto era così raro e prezioso che «orde di inglesi» andarono per due secoli a «saccheggiare le tombe dei faraoni, non in cerca di oro, tesori o reperti antichi, ma dell’azoto contenuto nelle ossa delle migliaia di schiavi con cui i re del Nilo si facevano seppellire». Quanti più cadaveri possibile delle battaglie napoleoniche, «più di tre milioni di scheletri», vennero riesumati e spediti in Inghilterra «dove venivano frantumati dai tritaossa dello Yorkshire per fecondare i verdi campi di Albione».
Ma lo stesso Haber, l’uomo che aveva fatto «il pane dall’aria», inventò l’iprite, gas a base di cloro, che nel 1915 diede inizio alla produzione delle letali armi chimiche. Alla battaglia di Ypres fu lui stesso a indicare dove porre le bombole piene di gas. La moglie, Clara Immerwahr, chimica come il marito ma pacifista, si suicidò. Haber, promosso capitano, non partecipò neppure al funerale: partì subito per coordinare i nuovi attacchi coi gas sul fronte orientale.
Tra le sostanze nuove che Haber creò dopo la guerra, ci fu il gas pesticida Zyclon, che prodotto dalla Bayer, nella sua variante B fu il gas usato nelle camere dei campi di sterminio.
Ingratitudine del mondo: nel 1933, Hitler diventò cancelliere. Ebbe subito inizio l’epurazione degli ebrei. Max Planck incontrò Hitler proprio per tentare di salvare la carriera dell’ebreo Haber. Hitler, furioso, pare che abbia detto lì che «se la scienza non può fare a meno degli ebrei, noi in pochi anni faremo a meno della scienza» (J. Bernstein, Einstein, il Mulino 1983), frase che oggi potrebbe suonare grottescamente profetica. Emigrato in Inghilterra, Haber trovò un ambiente molto ostile tra i colleghi dell’università di Cambridge, che ricordavano bene il suo ruolo nell’invenzione del «gas mostarda». Nel 1934, decise di trasferirsi in Palestina, ma morì durante il viaggio per un infarto in un albergo di Basilea, «abbracciato alla bombola che avrebbe dovuto dilatargli le coronarie». Così non poté mai sapere che il Zyclon che aveva inventato avrebbe ucciso pochi anni dopo molti della sua stessa famiglia. Haber sarebbe un bel caso per i fanatici della cancel culture, che s’illudono che si possa ridurre la storia alla memoria di ciò che ritengono bene.
Questa è la prima storia di Quando abbiamo smesso di capire il mondo. S’intitola Blu di Prussia perché Labatut è capace d’intrecciare il racconto della vita di un chimico, importante come forse nessun altro, con la scoperta di colori che magari riteniamo ovvi: il blu di Prussia usato per la prima volta nello splendido velo della Madonna nella Sepoltura di Cristo di Pieter van der Werff (1709) scoperto per caso all’inizio del ’700 e il verde luminoso di Scheele (1775), amato da Napoleone al punto da volere di quel colore la camera del suo esilio a Sant’Elena e che, pieno d’arsenico, lo uccise.
Il secondo racconto è dedicato a Karl Schwarzschild (1873 – 1916), astronomo e astrofisico che regalò ad Einstein nel 1915 la soluzione per completare la teoria generale della relatività; la sua formula «descriveva perfettamente il modo in cui la massa di una stella deforma lo spazio e il tempo circostanti». Quando Einstein gli rispose, Schwarzschild era morto, ucciso da una grave malattia della pelle: il pemfigo. L’ultima parte della sua vita era stata ossessionata dalla scoperta, che tra l’altro – e per lui soprattutto – implicava che una massa qualunque può concentrarsi al punto da piegare lo spazio-tempo attorno a sé stessa, in un collasso infinito, e che quest’evento sarebbe stato capace di attirare nel suo vortice tutto quanto fosse entrato nella sua sfera calamitante: è «la singolarità di Schwarzschild» circondata da quell’orizzonte degli eventi che si chiama a sua volta «raggio di Schwarzschild». Fu per lui stesso una scoperta inconcepibile e mostruosa: «il vero orrore è che la singolarità era il punto cieco, fondamentalmente inconoscibile», non solo perché impossibile da vedere ma perché impossibile da comprendere: lì, «la fisica, semplicemente, smetteva di aver senso». La scoperta che fosse possibile una tale concentrazione della gravità da lacerare in un buco impenetrabile il tessuto dello spazio-tempo fu qualcosa che fino alla morte tentò di esorcizzare, come un abominio non dell’universo ma della sua teoria.
E invece fu l’inizio della teoria dei buchi neri. Quella di Schwarzschild è una storia non meno appassionante di quella di Haber: divorato dal demone della conoscenza, scrisse «più di qualsiasi altro scienziato del XX secolo».
Il terzo racconto, Il cuore del cuore, è dedicato – soprattutto, ma non solo – alla vita di Alexander Grothendieck (1928 – 2014), figura imprescindibile per quel mondo per noi esoterico dei matematici, ai quali dobbiamo moltissimo e di cui non sappiamo nulla. La parabola della sua vita ricorda quella del grande scacchista Bobby Fischer, per il quale lo stesso mondo degli scacchi si fece troppo piccolo, che sempre più si isolò da tutti, genio in fuga dal mondo, preso da una visione apocalittica e alla fine paranoica di tutto. Ma Grothendieck non perse il senno, o almeno non lo perse del tutto. Dopo un viaggio in Vietnam nel 1967, dove insegnò in un’università che fu bombardata dagli americani provocando la morte di due professori e decine di studenti, «non era più lo stesso»: gli parve da allora impossibile separare la responsabilità dei politici da quella degli scienziati, che per lui ormai «camminavano come sonnambuli verso l’Apocalisse»: Hiroshima e Nagasaki, prima che decise da Truman, furono l’opera di «un gruppo di fisici armati di un pugno di equazioni»: impossibile svicolare rifugiandosi in una supposta neutralità della scienza. Rispetto a questo, la matematica alla fine gli apparve fatua se non malefica e con lei, forse, la stessa vita, almeno della gran parte di noi, sonnambuli.
Il cuore del libro di Labatut è la storia che dà il titolo al libro: Quando abbiamo smesso di capire il mondo. È la vicenda appassionantissima della nascita della fisica quantistica. Labatut ci racconta di Einstein, Bohr, Schrödinger (che tanti conoscono almeno per il paradosso del gatto chiuso in una scatola dove potrebbe essere vivo e morto nello stesso tempo), e soprattutto di Werner Karl Heisenberg (1901 – 1976). Giovanissimo, Heisenberg era «tormentato» da una domanda semplice e micidiale: perché le leggi che spiegano le stelle, i pianeti, le galassie e insomma il grande universo, quelle di Newton prima e di Einstein poi, non valgono nello spazio minimo degli atomi? Cosa accade perché un atomo non sia una specie di minimo sistema solare con la sua stella (il nucleo) al centro e i pianeti (gli elettroni) attorno a seguire orbite esatte e prevedibili? Perché non sappiamo neppure cosa siano quelle particelle, che forse, come quelle elettriche, non sono neppure particelle ma onde?
L’ossessione per questa «falla sostanziale» della fisica lo portò – come una Musa tormentosa e inderogabile – a definire sull’isola di Helgoland nel Mare del Nord il principio di indeterminazione, scoperta capitale che ha dato un colpo mortale a qualunque tipo di determinismo.
La conseguenza. dirà lo stesso Heisenberg, non fu niente di meno che questa: poiché il nostro intervento, anche la pura e semplice osservazione, «altera gli oggetti che indaga», «quando parliamo della scienza della nostra epoca, parliamo della nostra relazione con la natura non come osservatori obiettivi e separati, ma come attori del gioco tra l’uomo e il mondo». Rovelli ha scritto un saggio, Helgoland (Adelphi 2020), che è bello leggere in parallelo al libro di Labatut; lì riassume che «le proprietà di un oggetto che sono reali rispetto a un secondo oggetto non lo sono necessariamente rispetto a un terzo», e ci fa notare che Platone aveva già capito molto quando nel Sofista scrisse che possiamo chiamare reale solo ciò che è «azione»: ciò che è azione per noi. Persino Einstein non si rassegnò a un così radicale relativismo. Ma ebbe torto e «capitolò».
Tutto è raccontato da Labatut con la fluidità del grande narratore. La storia della scienza è qui anche storia degli scienziati; i suoi grandi momenti – Labatut le chiama epifanie – non appaiono più momenti angelici e algidi di una storia di puro pensiero, come se i protagonisti fossero stati come quel personaggio antipatico e puramente mentale che Paul Valéry chiamò Monsieur Teste. Labatut racconta storie di scienziati come si racconta da tempo la storia degli artisti: le cose, anche le grandi cose del pensiero, accadono nella vita, in giovinezze febbrili, negli eremi come nelle università, nei tubercolosari, tra eros anche perverso e morte, nello sporco irreparabile delle guerre, in grandi e anche malsane solitudini che possono rasentare la follia. E dunque, come chiese uno sconosciuto a Heisenberg in un bar di Copenaghen: quando abbiamo smesso di capire il mondo?
Benjamín Labatut
Quando abbiamo smesso
di capire il mondo
Adelphi, Milano 2021
- 180, euro 18,00